Monitorare gli alberi per capirne cambiamenti, possibili problemi o miglioramenti che si possono mettere in atto è la mission di Prospettiva Terra, un progetto non profit coordinato da Stefano Mancuso che aggrega imprese, organizzazioni, comunità scientifiche e istituzioni contro il cambiamento climatico. Sebbene i controlli degli esperti del verde restino essenziali, l’Intelligenza artificiale può arrivare in aiuto e ridurre significativamente i rischi per i cittadini che con gli alberi vivono a stretto contatto. Grazie a modelli intelligenti sofisticati è, infatti, possibile sapere in tempo reale se un albero è in salute, come evolvono le sue condizioni, se emergono anomalie o se corre il rischio di cadere. A spiegarci più nel dettaglio il progetto che nasce da uno spin-off dell’Università di Firenze e ha avviato una prima fase sperimentale nella Biblioteca degli Alberi di Milano è Camilla Pandolfi, CEO della srl PNAT per questa nuova puntata del nostro appuntamento con Viaggio in Italia.

Un progetto contro il cambiamento climatico
«Una delle conseguenze del riscaldamento globale è l’aumento dell’intensità dei fenomeni atmosferici. Questi si manifestano in forme sempre più violente, sottoponendo gli alberi a stress meccanici cui non sono abituati e provocando, soprattutto in ambiente urbano, in condizioni di stabilità non sempre perfette, un numero crescente di cadute – spiega Stefano Mancuso, accademico e divulgatore scientifico – Poiché l’aumento di copertura arborea nelle città è la soluzione fondamentale e imprescindibile per combattere le cause e gli effetti del riscaldamento globale, è necessario immaginare dei sistemi di ausilio all’indagine umana, che avvisino della possibile diminuzione di stabilità di un albero». Quello che ha messo a terra PNAT, inizialmente spin-off dell’Università di Firenze poi diventata srl, con il supporto di Prospettiva Terra, è un progetto sostenuto da Henkel, Ricola, Omnicom Media Group e McDonald’s che riunisce attorno a sé diversi enti. Attraverso dei modelli di Intelligenza artificiale che interpretano i dati raccolti da una serie di sensori, si riceve un allarme quando c’è qualcosa che non va all’interno di un contesto urbano, contribuendo a prevedere eventuali cadute, incidenti e gestire con maggiore sicurezza il verde urbano, soprattutto in relazione ai rischi meteorologici. La prima sperimentazione è iniziata due anni fa in BAM – Biblioteca degli Alberi di Milano, progetto della Fondazione Riccardo Catella, dove sono stati installati sensori su 300 alberi.
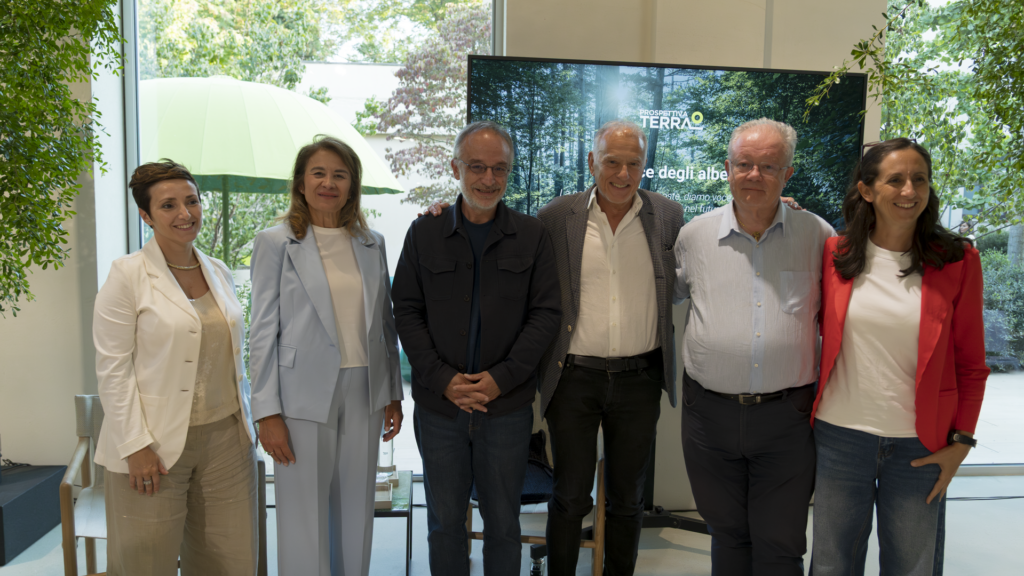
La prima sperimentazione in BAM
«Attraverso le nostro soluzioni tech con sensori e dispositivi IoT – spiega Camilla Pandolfi – Nel BAM possiamo monitorare la stabilità degli alberi con un sistema di comunicazione che invia una serie di dati a un cloud. In questo modo, si acquisiscono le vibrazioni degli alberi, le monitoriamo in tempo reale e abbiamo a disposizione un’impronta digitale della pianta. Il fine è quello di avere sotto controllo questa impronta digitale nel tempo per prevederne i cambiamenti nel caso in cui l’albero sia sofferente, morente o presenti una situazione compromessa per cui potrebbe cadere, spezzarsi o fare danno a cose e/o persone». Quale luogo migliore se non quindi la Biblioteca degli Alberi di Milano per sperimentare una soluzione del genere? In pieno centro città, qui è presente una grande varietà di piante. «Due anni fa abbiamo avviato la prima sperimentazione di 300 sensori su 300 alberi. Questo per noi è come un laboratorio». Camilla e il suo team durante il primo anno di monitoraggio hanno acquisito i dati e hanno iniziato a mettere in piedi algoritmi di machine learning che fossero in grado di analizzarli e prevedere i comportamenti futuri e capaci di elaborare grandi volumi di dati, individuare pattern ricorrenti e migliorare nel tempo le proprie previsioni. Questo approccio ha permesso di costruire un sistema dinamico, in grado di apprendere e affinare la sua sensibilità man mano che aumentano le situazioni osservate. «Uno dei pillar del progetto è mettere a punto questa infrastruttura di canalizzazione dei dati che permette di comprendere i cambiamenti delle stagioni – continua la CEO – Per fare un esempio, un albero che va in riposo vegetativo ha una vibrazione diversa rispetto a una fase vegetativa. Così siamo in grado di capire in quale fase fisiologica dell’albero ci troviamo e generare allerte e attese qualora i valori misurati non rientrino in un preciso range».

Attraverso una serie di strumenti tech, come il sensore per la stabilità e il monitoraggio degli alberi, il team mette a punto una scheda completa di dati che non vuole sostituirsi alla valutazione umana ma la vuole supportare. «Oggi la stabilità degli alberi viene valutata da esperti che a intervalli periodici ispezionano pianta per pianta – precisa Camilla – valuta deformità e problematiche a livello macroscopico, prescrive strumenti che permettono di valutare la completezza del fusto, valuta la propensione al cedimento e comprende lo stato di salute della pianta. Una volta terminato il monitoraggio, i valutatori segnano a questi alberi una data di controllo». Ora, pensiamo a una pubblica amministrazione che deve gestire migliaia di alberi, si tratta di un costo molto oneroso. «Il nostro strumento può invece fornire un valido aiuto anche in situazioni di criticità come, ad esempio, la vicinanza a una scuola o in un posto ad alta frequentazione con un controllo in tempo reale che possa prevenire eventuali incidenti». I sensori, autonomi dal punto di vista energetico, registrano costantemente alcuni parametri chiave come l’inclinazione del tronco e la frequenza naturale di oscillazione, dati utili per valutare in modo oggettivo la stabilità della pianta. Come delle “sentinelle”, sono in grado di lanciare un alert se qualcosa non va e riconoscere cambiamenti progressivi nello stato di stabilità e salute.

Il progetto PNAT e Prospettiva Terra
La CEO ci racconta come è nata l’idea: «Si tratta di un’iniziativa che è nata nel 2016, poi sono stati realizzati piccoli prototipi e, anche grazie ad altri finanziamenti, piccole installazioni pilota. Per noi l’arrivo al BAM è stato un momento importante perché qui abbiamo messo in campo un gran numero di sensori e gestito milioni di dati». PNAT, oggi srl nata come spin-off dell’Università di Firenze sotto la guida del prof. Mancuso assieme a professionisti, botanici e architetti, ha sede a Firenze, nell’ex manifattura tabacchi e conta un team di 13 persone. «Ci troviamo in un complesso di 16 edifici oggetto di rigenerazione urbana dal 2019».

Conclusa la prima fase sperimentale, il passo successivo prevede l’applicazione del sistema a contesti più complessi, come viali alberati e grandi parchi cittadini con alberature adulte, per validare ulteriormente i modelli sviluppati e testare l’efficacia delle allerte generate in situazioni più dinamiche e potenzialmente critiche. Tra i progetti nel cassetto di Prospettiva Terra c’è quello di ampliare il raggio d’azione, come racconta Camilla: «Vorremmo fare più installazioni a Milano, in contesti più realistici come i viali alberati, con alberi più maturi e classi di stabilità più difformi per potenziare la capacità dei nostri modelli».



