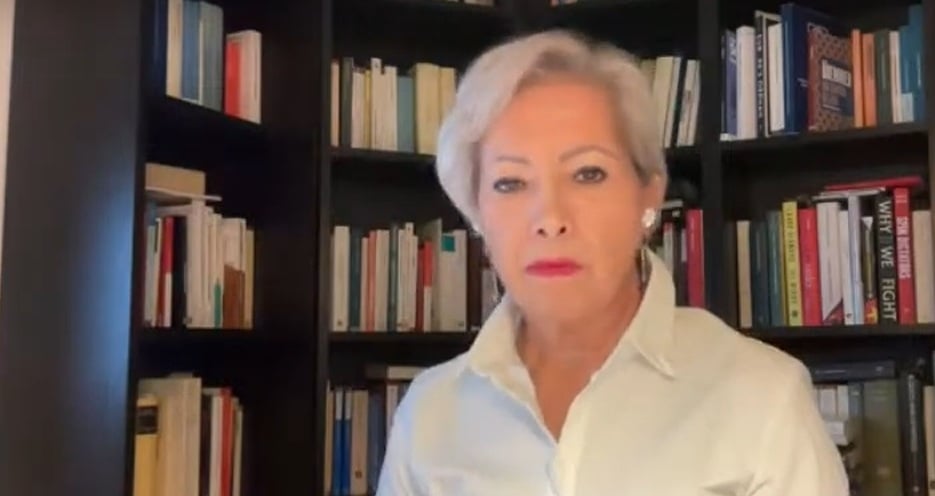Quali sfide attendono la società di domani? Quali sono i rischi e quali le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico? Per la rubrica “Futuro da sfogliare” un estratto del libro Dominio di Adriana Castagnoli, edito da Il Sole 24 Ore.
***
«L’ordine globale del dopoguerra non è solo obsoleto», ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio durante la sua audizione di conferma al Senato. «È ormai un’arma che viene utilizzata contro di noi». Dopo la fine della Guerra Fredda, gli Stati Uniti hanno esercitato la leadership globale in modo pressoché unilaterale. Ma oggi gli equilibri sono cambiati e le opinioni sul loro ruolo appaiono divise. Alcuni prevedono che gli Stati Uniti rimarranno l’egemone globale per il prossimo futuro, altri affermano che siamo diretti verso una nuova competizione bipolare con la Cina, altri ancora credono che stia sorgendo un’era multipolare. Certamente gli Stati Uniti e la Cina sono in testa alla competizione per il dominio, ma il potere economico e militare è cresciuto anche altrove, seppur variamente distribuito e composto: dall’Australia alla Turchia, dal Brasile all’Arabia Saudita, dal Giappone all’India le potenze medie o in ascesa sono significativamente più influenti di quanto fossero un tempo e rivestono una funzione chiave a livello regionale.

Emma Ashford ed Evan Cooper, in un recente studio, dimostrano che, contrariamente al periodo della Guerra Fredda, quando Stati Uniti e Unione Sovietica detenevano congiuntamente la maggior parte del potere economico e militare globale, adesso insieme Cina e Stati Uniti controllano una quota relativamente inferiore. Secondo un indice che misura la combinazione di potenza economica e militare, tale quota sarebbe diminuita dal 40% circa, registrato nel 1946, a soltanto il 30% circa nell’attuale scenario internazionale. «La quota dell’economia globale detenuta da Washington, Mosca e dai rispettivi blocchi alleati ammontava a ben l’88% del PIL mondiale nel 1950; oggi, questi Paesi costituiscono soltanto il 57% del PIL globale.
Tale potere si è progressivamente diffuso altrove, spostandosi dalle superpotenze verso una pluralità di medie potenze capaci e dinamiche, che contribuiranno significativamente a plasmare l’assetto internazionale nei decenni a venire». In pratica, siamo entrati in un periodo di multipolarità asimmetrica. In un mondo di potere economico più regionalizzato e con un potere relativo in diminuzione, il governo degli Stati Uniti avrà difficoltà a imporre la propria volontà in ogni scacchiere del mondo, soprattutto contemporaneamente. La guerra in Ucraina ha evidenziato questa dinamica: gli Stati disposti a collaborare con Washington contro la Cina sono sovente meno propensi a impegnarsi nel sostenere la posizione degli Stati Uniti sulla questione ucraina. L’India, ad esempio, è una parte sempre più importante della strategia statunitense nell’Indo-Pacifico, ma continua a importare energia e armi dalla Russia.
Nel frattempo, in Europa, la Germania rimane un partner commerciale rilevante di Pechino mentre coopera strettamente con gli Stati Uniti sulla questione ucraina. Un insieme di potenze medie con interessi divergenti probabilmente non si unirà mai in un blocco globale coerente, preferendo alleanze a geometria variabile e di scopo2. La Cina cominciò a rivedere il suo rapporto con l’ordine internazionale nel 2008, quando la grave crisi economico- finanziaria internazionale colpì gli Stati Uniti, l’UE e altri Paesi occidentali.
Nella fragilità degli equilibri politici globali, Pechino colse l’opportunità per realizzare la nuova dottrina della sua politica estera che mira non solo a riformare le istituzioni internazionali esistenti, bensì a edificarne di nuove per implementare la “democratizzazione delle relazioni internazionali”. Il punto di vista di Pechino è che le decisioni in merito all’ordine internazionale non dovrebbero essere prese soltanto dagli USA e dai loro alleati in Europa e in Asia, ma da tutti gli Stati membri dell’ONU. Per promuovere questa dottrina, il Politburo ha avviato unilateralmente progetti infrastrutturali come la Belt and Road Iniziative e istituzioni finanziarie come la New Development Bank e l’Asian Infrastructure Investment Bank per favorire la realizzazione delle infrastrutture nei Paesi in via di sviluppo e della rete di connettività (di trasporto, digitale, energetica ed idrica), all’interno dell’Asia e tra l’Asia e il resto del mondo, che fa capo a Pechino. Pechino si è proposta come forza propulsiva della globalizzazione.
Nel suo discorso all’assemblea ONU, nel 2015, per celebrarne il 70° anniversario, il leader Xi Jinping lanciò una serie di iniziative per rafforzare la governance globale. Se nella propria narrazione politica Pechino amplifica il ruolo riformatore della Cina nell’ordine internazionale, in pratica tuttavia ha una funzione conservatrice su questioni cruciali come la riforma del Consiglio di sicurezza dell’ONU. L’approccio della Cina all’ordine internazionale si fonda su quattro pilastri: il riconoscimento del suo status di grande potenza, in particolare da parte dell’America, e di un mondo multipolare “equo e ordinato”; le relazioni con i vicini in Asia orientale, ritenuta una sua sfera di influenza prioritaria; le relazioni con i Paesi in via di sviluppo, il Global South, insieme ai quali promuove il proprio modello per cambiare l’ordine internazionale dall’interno; la pratica del multilateralismo3. Dall’elezione di Trump nel 2016 il coinvolgimento USA nel sistema liberale multilaterale si è molto indebolito. Ciò ha rafforzato il ruolo della Cina che adesso si erge a paladina del free trade e degli accordi multilaterali. Pechino ha registrato un riavvicinamento con il Giappone, mentre il protezionismo e le pratiche scorrette hanno reso più difficoltosi gli accordi con UE e Canada.

D’altra parte, l’idea di multilateralismo di Pechino differisce dall’approccio dell’UE: il concetto cinese è compatibile con le strategie delle grandi potenze e permette a Pechino di partecipare alla governance globale a costi limitati; invece quello europeo cerca di accrescere le limitate prerogative di potenza dell’UE sperando di vincolare così le grandi potenze “ordinanti” entro “l’istituzionalismo universale”. S
ia Washington sia Pechino rivendicano il proprio “eccezionalismo”. In un mondo divenuto più complesso e più conflittuale anche per la portata e la velocità del cambiamento indotto dall’innovazione tecnologica nelle relazioni internazionali, che è senza precedenti nella storia, politicamente frammentato e dove le questioni di sicurezza si sono regionalizzate, l’asse del nuovo potere globale è costituito da USA e Cina: rivali strutturali che, fra interdipendenza e competizione, stanno cercando di modellare il futuro ordine mondiale4. L’ascesa della Cina ha posto una nuova sfida per la diplomazia americana per mantenere o costruire la sua posizione politica nell’Asia orientale, sudorientale e meridionale. Mentre in Africa, America Latina, Europa e Asia centrale la crescente importanza della Cina è divenuta evidente in una varietà di ordini regionali.
La Cina è stata il pivot di un’alleanza tra quattro autocrazie: Cina, Iran, Corea del Nord e Russia, con le quali ha condiviso l’obiettivo di indebolire gli Stati Uniti collaborando in ambito militare, economico, tecnologico e diplomatico. Tuttavia, Pechino evita di essere formalmente identificata come leader di questo gruppo per scongiurare alienazioni diplomatiche dei suoi partner commerciali occidentali e regionali6. Ha fornito aiuto a Russia, Corea del Nord e Iran attraverso il commercio di tecnologia militare e l’acquisto di risorse naturali. Pechino mantiene una retorica di neutralità, evitando impegni formali che la leghino strettamente a questi partner. Questo approccio le permette di minimizzare le ripercussioni negative sul piano internazionale.
Gli scontri tra grandi potenze sono scontri di interessi e di idee. L’amministrazione Biden aveva definito la minaccia dei rivali degli Stati Uniti, in primis la Cina, in termini segnatamente ideologici. La competizione di Washington con Pechino e Mosca è stata narrata come l’ultimo round di una lunga lotta per decidere se il mondo sarà plasmato dalle democrazie o dagli autocrati, iniziata con la Prima guerra mondiale e proseguita, con brevi interruzioni come quella determinata dal crollo dell’URSS, sino a oggi. Ogni volta, gli Stati Uniti sono intervenuti per garantire la loro sicurezza e per mantenere l’equilibrio di potere consentendo l’espansione del liberalismo e la sopravvivenza della democrazia. Adesso, la competizione USA-Cina si connoterebbe come una prova decisiva di quale modello politico possa meglio soddisfare le esigenze dell’era moderna.
Ma, in un mondo frammentato e più multipolare, questa strategia potrebbe essere controproducente. Secondo Oriana Skylar Mastro, invece è cruciale che Washington sia realista evitando anche una retorica che contrapponga democrazie ad autocrazie, per non alienare i potenziali partner nel mondo in via di sviluppo8. USA e Cina, i due Paesi con i sistemi produttivi globalmente più interconnessi, sono destinati a dominare l’economia del XXI secolo cercando la supremazia nelle tecnologie informatiche, militari, biotecnologiche, dell’energia pulita.
Queste dinamiche di “interdipendenza armata” hanno modificato anche i confini fra governi e grandi corporation, relazioni internazionali e commercio che si sono offuscati tanto da divenire evanescenti (come dimostra il caso di Elon Musk e del suo sistema di comunicazione Starlink). L’ambiguità strategica di Pechino nel suo rapporto con Iran, Corea del Nord e Russia riflette un preciso calcolo politico: sfruttare l’alleanza informale per contrastare gli Stati Uniti senza compromettere le proprie relazioni con partner occidentali cruciali per la sua economia.
Pechino ha negato di essere parte di un “blocco antioccidentale,” come dichiarato nel 2023 dal Premier Li Qiang e già sottolineato nel 2016 dal viceministro degli Esteri Fu Ying. In questo modo, la Cina cerca di preservare le proprie relazioni economiche e diplomatiche globali dall’ostilità dei tre alleati verso Stati potenti come Germania, Giappone e Arabia Saudita, che potrebbero comprometterne gli interessi. Nel 1950, all’inizio della Guerra Fredda, il Partito Comunista Cinese e il Partito Comunista Sovietico formalizzarono un Trattato di amicizia, alleanza e assistenza reciproca della durata di 30 anni. In pratica, tuttavia, il rapporto tra Cina e Unione Sovietica si complicò rapidamente.
Oggi, il rapporto della Cina con gli antagonisti degli Stati Uniti è di nuovo a metà strada: né completamente coinvolto né completamente distaccato. Pechino, ad esempio, non ha appoggiato l’invasione dell’Ucraina né fornito aiuti militari diretti, e il ministero degli Esteri cinese ha definito una questione bilaterale tra Mosca e Pyongyang il trattato, siglato nel giugno e ratificato nel novembre 2024, con cui Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un si sono impegnati a sostenersi militarmente in caso di attacco.
Più inquietante per l’UE è che, in modi diversi, gli Stati Uniti, la Russia e la Cina sono altrettante potenze revisioniste che stanno cercando un radicale cambiamento dello status quo. I tradizionali alleati dell’America sono fra i Paesi che si sentono più minacciati dal modo in cui gli USA di Trump esercitano il potere. Le medie democrazie (Giappone, Canada, Sud Corea, Regno Unito) e l’intera UE sono abituate a un mondo in cui gli Stati Uniti rappresentano mercati aperti e una garanzia contro le minacce di potenze autoritarie. Adesso, a livello di narrativa per l’audience nazionale, Trump proclama che il nuovo ordine accrescerà la ricchezza e il potere dell’America. Invece Putin, come ha dichiarato a Sochi il 7 novembre, due giorni dopo l’elezione di Trump, vede che, in gioco, c’è la fine del monopolio del potere occidentale emerso dopo il crollo dell’URSS: «Davanti ai nostri occhi sta emergendo un nuovo ordine mondiale». Anche Xi Jinping ha osservato il declino del potere occidentale come cruciale e auspicabile per il nuovo ordine mondiale emergente.
D’altra parte, Mosca e Pechino hanno promosso i BRICS come contrappeso al G7 dominato dall’Occidente. Entrambi hanno specifiche rivendicazioni territoriali e di sfere di influenza: Taiwan, il Mar della Cina meridionale, l’Ucraina e altro. Ma, ragioni di sicurezza nazionale sono utili a giustificare anche l’aggressiva narrazione di Donald Trump che rivendica il controllo del Canale di Panama, l’acquisizione della Groenlandia, l’annessione del Canada. Il principio del dominio è might-is-right, la legge del più forte.