Quali sfide attendono la società di domani? Quali sono i rischi e quali le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico? Per la rubrica “Futuro da sfogliare” un estratto del libro Più turismo per tutti? di Paolo Verri ed Edoardo Colombo, edito da Egea.
***
C’è stato un tempo in cui il turismo era un privilegio di pochi, un’esperienza straordinaria e desiderata – talvolta anche un po’ temuta – capace di cambiare la vita di chi partiva e di chi accoglieva. Oggi il turismo è ovunque: più destinazioni, più offerte, più eventi, più persone in movimento, più viaggi. Eppure, questa crescita ha portato con sé nuove contraddizioni. Le città d’arte sono spesso invase da folle che tolgono spazio e servizi ai residenti, i prezzi salgono sia per chi visita sia per chi vive nei centri storici, le economie locali rischiano di diventare monoculture turistiche e la promessa di una democrazia del viaggio sembra svanire dietro una cortina di esclusione, disagio e conflitto. In uno scenario del genere ha ancora senso cercare “Più turismo per tutti?” La domanda, che non ha una sola risposta, anima la conversazione tra Paolo Verri ed Edoardo Colombo, in questo estratto che anticipa molti dei temi del loro libro edito da Egea.
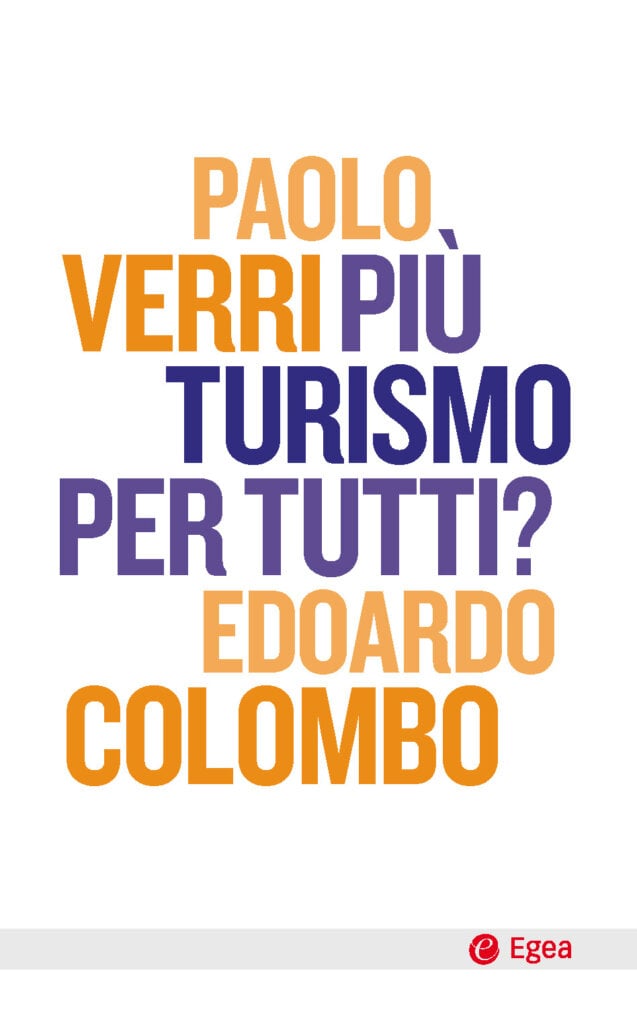
Paolo Verri – Ogni anno più di un miliardo di persone si muove nel mondo per turismo. Sono migranti temporanei, viaggiatori che attraversano confini, culture, lingue, storie. È un movimento enorme, uno dei pochi fenomeni veramente globali, capace di generare incontro, conoscenza, scambio. Ma anche tensioni, fragilità, responsabilità. È da qui che nasce il valore positivo del viaggio: dalla sua capacità di generare connessioni reali tra popoli diversi.
Edoardo Colombo – I numeri ci mostrano una realtà straordinaria: il turismo rappresenta la più grande infrastruttura pacifica mai costruita dall’umanità. Non c’è esercito, organizzazione internazionale o trattato diplomatico che abbia fatto muovere così tante persone in così poco tempo, e sempre in modo pacifico. I dati del 2023 parlano di oltre 1,4 miliardi di viaggiatori internazionali, persone che hanno scelto di incontrare l’altro anziché temerlo. In un’epoca di conflitti e chiusure, il turismo è uno dei pochi fenomeni che continua a costruire ponti anziché muri.
Paolo Verri – Eppure c’è una contraddizione potente: proprio quando più persone viaggiano, nel mondo si combattono guerre, si alzano muri, si costruiscono nuove disuguaglianze. Pensiamo a quel che sta succedendo in Ucraina o in Medio Oriente. Il turismo può essere uno strumento di pace solo se è consapevole del contesto in cui si inserisce. Altrimenti rischia di diventare indifferente o, peggio, complice. Mi vengono in mente splendide spiagge non lontane da zone di conflitto, trasformate in destinazioni mentre a pochi chilometri si consuma una tragedia. È in questi casi che bisogna interrogarsi sul senso profondo del viaggio.
Edoardo Colombo – Oggi abbiamo strumenti per rendere trasparenti le filiere, per tracciare l’impatto economico, per assicurarci che il valore generato rimanga sui territori. Un sistema turistico che consuma risorse e non lascia benefici sul territorio non è sostenibile né eticamente né economicamente. La vera sfida è usare l’innovazione per trasformare il turismo in un motore di riconversione ecologica, di cooperazione tra territori. Le piattaforme digitali, analizzando i flussi in tempo reale, possono aiutarci a distribuire meglio le presenze, a valorizzare destinazioni meno conosciute, a premiare comportamenti virtuosi.
Leggi anche: Cosa serve per creare – e comunicare – un brand vincente
Paolo Verri – Quando qualche anno fa abbiamo coniato il concetto di turista come «cittadino temporaneo» pensavamo esattamente a questo: una presenza che ha diritti ma anche doveri. Che ha il privilegio di attraversare un luogo, ma anche la responsabilità di rispettarlo. Non è una visione astratta: se cominciassimo a pensare in questi termini, cambierebbe tutto: la pianificazione urbana, l’offerta di servizi, le relazioni. Il viaggio non sarebbe più evasione, ma partecipazione.

Edoardo Colombo – Questo cambio di paradigma potrebbe tradursi concretamente attraverso strumenti come la tassa di soggiorno. Oggi percepita in modo negativo dai turisti e mal sopportata dagli albergatori che devono agire da sostituti di imposta, in pratica esattori senza benefici, anzi con i costi di gestione della movimentazione pecuniaria, la tassa di soggiorno potrebbe trasformarsi in un vero e proprio «contributo di cittadinanza temporanea». Attivando una relazione nel momento dell’arrivo in albergo, si potrebbero proporre sconti e servizi gratuiti, per esempio sui trasporti pubblici, in musei meno conosciuti o in esercizi convenzionati…
Paolo Verri – … come il blocchetto di coupon che ti davano una volta negli uffici turistici…
Edoardo Colombo – Proprio così! Sarebbe anche un modo per indurre comportamenti responsabili e, grazie al consenso ottenuto e alla profilazione, si potrebbero suggerire spunti mirati e potenzialmente interessanti su mostre temporanee, eventi e manifestazioni che potrebbero convincere il turista ad allungare la permanenza. Anche gli alberghi e le strutture ricettive potrebbero proporre i loro esercizi convenzionati attivando un network a cui riconoscere un diritto di segnalazione.
Paolo Verri – Sarebbe una forma concreta di partecipazione civica; ma potremmo spingerci oltre, immaginando forme di rappresentanza consultiva del turista nei processi decisionali locali. Del resto, in città dove in certi periodi dell’anno i visitatori sono spesso più numerosi dei residenti non sarebbe così assurdo che i primi avessero voce sulle scelte che riguardano il patrimonio culturale o i servizi pubblici. Significherebbe transitare da un modello passivo di consumo a uno attivo di partecipazione.
Edoardo Colombo – Sai che cosa mi piacerebbe proporre a Roma? Che al momento del pagamento della tassa di soggiorno, ogni visitatore riceva una pergamena digitale che gli conferisca l’antico titolo di civis Romanus. Un gesto semplice ma ricco di significato. Nella Roma antica pronunciare le parole «civis Romanus sum» equivaleva a invocare protezione e diritti ovunque ci si trovasse. Perché non riprendere quel simbolo oggi, in chiave contemporanea, e trasformarlo in un riconoscimento onorifico per chi sceglie Roma? Come disse John Fitzgerald Kennedy, «Duemila anni fa, il vanto più grande era poter dire “civis Romanus sum”. Oggi, nel mondo della libertà, il vanto più grande è dire “Ich bin ein Berliner”». Non si tratterebbe solo di un ricordo del viaggio, ma di un legame che resta. Il titolo potrebbe essere mantenuto nel tempo attraverso una quota annuale, anche senza tornare fisicamente in città, e dare accesso a piccoli benefici: sconti culturali, accessi digitali, anteprime. Un modo per trasformare il turista in cittadino temporaneo, e poi in ambasciatore permanente.
Paolo Verri – Torna l’idea del turista come cittadino temporaneo. Non è un’utopia: è un’idea politica. Se la pratichiamo, cambiano anche le aspettative. Non si va più solo a consumare, ma a capire. Non si cerca solo il comfort, ma il contesto. È una postura diversa, che ci interroga anche come comunità ospitanti. Perché accogliere qualcuno non è mai solo offrirgli un letto: è offrirgli un pezzo del proprio mondo, della propria storia, della propria identità.
Edoardo Colombo – Potrebbe addirittura diventare l’emblema di un nuovo patto fra turista e comunità. Immaginiamo una tassa di soggiorno trasparente, dove chi viaggia può vedere come quel contributo venga investito nel territorio: se il turista sapesse esattamente dove vanno quei soldi, se potesse vedere come migliorano la città che sta visitando, si creerebbe un patto di corresponsabilità.

Paolo Verri – Non più un anonimo prelievo, ma uno strumento di coprogettazione urbana. Se un turista vedesse chiaramente che il suo contributo migliora gli spazi pubblici, sostiene servizi culturali, rigenera aree dismesse, probabilmente lo pagherebbe non solo con rassegnazione ma con convinzione e si comporterebbe con maggior rispetto.
Edoardo Colombo – Alcuni Comuni hanno già iniziato a sperimentare questo modello introducendo un sistema di rendicontazione pubblica dei proventi della tassa di soggiorno. I risultati sono interessanti: maggiore trasparenza significa maggiore accettazione, persino coinvolgimento.
Paolo Verri – Anche in questo caso possiamo andare oltre. Immagina una app in cui il turista non solo vede come viene usato il suo contributo, ma può anche esprimere preferenze, suggerire progetti, partecipare a un processo decisionale collettivo.
Edoardo Colombo – La tecnologia può davvero diventare un alleato di questa nuova forma di cittadinanza temporanea. La app IO, con il rilascio imminente di soluzioni di identità digitale europea secondo standard che sono già stati sperimentati con il green pass in oltre ottanta Paesi, potrebbe diventare strumento di pagamento e mostrare in tempo reale l’impatto del contributo: un intervento di restauro, la riqualificazione di uno spazio verde, il supporto a un progetto culturale…
Paolo Verri – Sarebbe un modo per trasformare il turista da consumatore passivo a coprotagonista. Non più qualcuno che attraversa un luogo, ma qualcuno che contribuisce alla sua rigenerazione. Un piccolo contributo che diventa un atto di cittadinanza, che ci consente di allargare la prospettiva oltre le città d’arte, guardando a quelle aree interne che costituiscono la spina dorsale più autentica e fragile del nostro Paese.
Edoardo Colombo – Soprattutto sarebbe un modo per costruire un legame più profondo. Non si tratta solo di trasparenza fiscale, ma di creare una connessione emotiva con il territorio. Il turista diventa parte, sia pure temporaneamente, di un progetto collettivo. Il turismo, infatti, a differenza di molte altre attività economiche, è potenzialmente presente in tutti i diciassette obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Può ridurre la povertà (SDG 1), contribuendo alla creazione di occupazione locale; può combattere la fame (SDG 2) stimolando l’economia agricola legata all’approvvigionamento turistico; può promuovere salute e benessere (SDG 3), sostenendo infrastrutture sanitarie accessibili anche ai visitatori; può incentivare un’istruzione di qualità (SDG 4) attraverso percorsi di formazione professionale. Non sono teorie: sono meccanismi economici e sociali misurabili, che possiamo implementare e verificare.
Paolo Verri – È proprio in questa capacità trasversale che il turismo dimostra il suo potenziale trasformativo. Non si tratta solo di portare persone da un punto A a un punto B. Si tratta di investire nelle infrastrutture locali, nella qualità della vita, nella sicurezza, nella cura. In molti Paesi costruire una struttura turistica significa portare elettricità, acqua potabile, connessione digitale: cioè i prerequisiti per una cittadinanza piena. Ci sono esempi provati di queste trasformazioni ormai nelle parti più remote del pianeta: il turismo diventa un acceleratore di diritti e di dignità.



