Settembre è il mese dei cambiamenti e dei buoni propositi. Ci sentiamo più motivati a iniziare nuovi progetti, sia personali che professionali. Siamo mentalmente ben disposti a non fare gli stessi errori introducendo dei cambiamenti nella nostra routine di vita e di lavoro. Il cambiamento necessario per raggiungere il successo non attiene tanto a fattori esterni, quanto a una trasformazione interiore. È sempre un cambio di abitudini, di mindset o di approccio. Per alcuni il cambiamento riguarda la capacità di padroneggiare l’arte della scelta: scegliere nonostante la paura di sbagliare. Fare scelte e prendere decisioni sono le nostre due attività quotidiane.
Leggi anche: Perché per le grandi aziende (e non solo) è così difficile chiedere scusa e ammettere l’errore?
Spesso nel dubbio e per evitare di commettere errori, facciamo scelte prudenziali, prive o quasi di rischi. Alcuni si spingono anche oltre scegliendo di non scegliere. La mancata scelta riduce la probabilità di cadere in errore, ma non elimina potenziali conseguenze negative. Nelle aziende spesso si preferisce assumere questa abitudine per evitare ritorsioni o richiami. Le storie che raccontiamo in questa rubrica mettono tutte in evidenza un aspetto forse controintuitivo. Solo chi si assume la responsabilità di una scelta anche rischiosa e accetta la possibilità di sbagliare, riesce ad innovare e a cogliere le opportunità dietro agli ostacoli. I ricercatori hanno individuato 4 tipologie di personalità che si approcciano alla fase della scelta in modo differente sebbene abbiano tutti un filo rosso in comune: la paura di fallire. Le 4 figure sono: il perfezionista, l’indeciso, il procastinatore, l’ipergeneralista. In quale di queste figure ti rivedi?

La perfezione? Un intervallo tra due errori
Nel libro di Walter Isaacson, Steve Jobs, sua moglie Laurene Powell Jobsconfessa: «Abbiamo parlato di arredamento in teoria per 8 anni. Abbiamo passato molto tempo a chiederci qual è lo scopo di un divano». La scelta di una lavatrice si è rivelata ancora più ardua. In un articolo della rivista Wired, Jobs descriverà con meticolosità il processo decisionale che lo portò all’acquisto di una nuova lavabiancheria tedesca. Quando si trattava di prendere una decisione che riguardasse argomenti personali, problemi lavorativi o la gestione dell’azienda Jobs impiegava molto tempo. Aveva bisogno che le cose fossero perfette. O ignorava le cose che non voleva affrontare. Come la sua malattia.
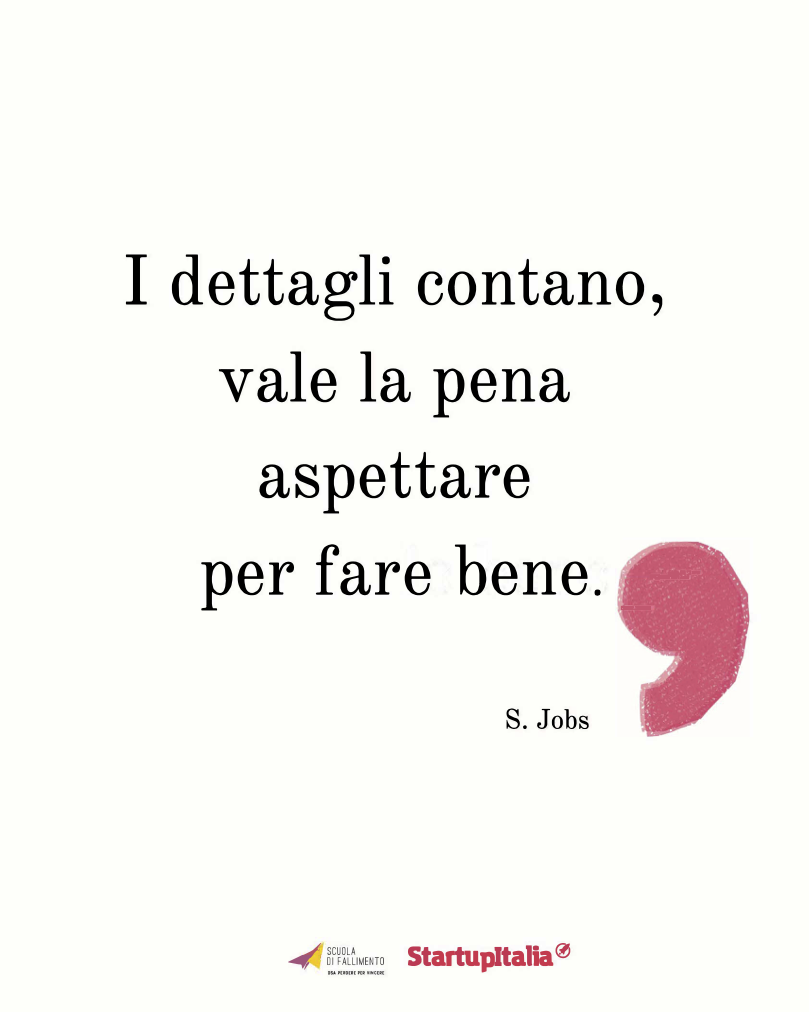
«L’irascibilità e l’impazienza erano componenti essenziali del suo perfezionismo» controbatte il suo biografo ufficiale, Isaacson. Il perfezionismo di Jobs era leggendario perché al limite del fastidioso e dello scortese. Durante uno dei suoi ricoveri in ospedale, incontrò 77 infermiere prima di trovarne 3 di suo gradimento. Allo pneumologo che era in procinto di appoggiargli una mascherina sul viso, Jobs gliela strappò dalle mani, perché ne detestava il design.
Anche se riusciva a malapena a parlare, ordinò al medico di portargli 5 diverse opzioni di mascherine. Lui avrebbe scelto quella con il design migliore. Suggerì un modello più semplice per il rilevatore dell’ossigeno. Seppur malato, continuò a lavorare per progettare la nuova sede Apple di Cupertino, focalizzandosi su tutti i particolari, ad esempio i vetri. Gli architetti volevano che le finestre fatte di vetro si aprissero. Jobs rispose che «non gli era mai piaciuta l’idea che le persone fossero in grado di aprire le cose. Questo permetterebbe alle persone di rovinarle». Era attento a ogni sfumatura dell’ambiente che lo circondava, e questo contribuiva a prostrarlo, ricorda sua moglie.

Il perfezionista ha un’ossessiva attenzione ai dettagli, soppesa ogni singola soluzione alla ricerca di quella perfetta. Non è un caso forse che Jobs più che un inventore fosse un tweaker, un abile perfezionatore di idee altrui. Sebbene detestasse chiunque tentasse, a suo dire, di copiare i suoi prodotti, soprattutto Google e Microsoft, «il suo dono stava nel prendere ciò che era davanti a lui e perfezionarlo spietatamente» fino al punto che da rendere immodificabili i suoi prodotti. Jobs ha sempre optato per un’architettura software chiusa, impedendo che l’iPhone, l’iPod e l’iPad venissero aperti o modificati. Per lui erano per lui opere perfette.
I perfezionisti hanno spesso difficoltà a concentrarsi sulle priorità. Investono tempo ed energie in cose irrilevanti o di secondaria importanza. L’ ossessione di Jobs per la perfezione si estendeva alle cose invisibili, una lezione appresa da bambino. «Se una cosa è fatta bene o male, non lo saprà nessuno. Ma lo saprai tu», gli ripeteva il padre.
Steve Jobs e quell’ossessione per la perfezione
Le conseguenze di questa ossessione? Ritardi nei progetti e spese eccessive, spesso per migliorie non necessarie. E una visione a tunnel nella quale si perde la percezione di ciò che sta intorno perché si mantiene un’attenzione rigidamente stretta. Nel progetto iniziale, lo schermo degli iPhone di vetro detto Gorilla Glass era inserito in una cassa di alluminio. Le preoccupazioni perfezionistiche tolsero il sonno a Jobs. Il suo mentore, Mike Markkula, gli ripeteva che un libro si giudica dalla copertina e che la gente attribuisce un valore positivo al prodotto sulla base della presentazione, del design e dell’imballaggio. La mattina successiva si rivolse al team dei designer con queste parole «Ragazzi, vi siete ammazzati su questo progetto per nove mesi, ma bisogna cambiarlo. Dovremo lavorare tutti anche la notte e i weekend e, se volete, vi diamo delle pistole perché ci possiate immediatamente sparare». I perfezionisti sono consapevoli delle loro pretese.

Il perfezionista è controllante ed esigente. Non si accontenta di niente di meno della perfezione. Rifiuta i risultati negativi o sotto la media perché ha una stima di sé condizionata dalla performance. Il perfezionismo di Jobs era eterodiretto, ovvero orientato anche verso l’altro: non era tollerante nei confronti degli errori altrui ed era pronto a criticarli in caso di insuccesso, a sminuirli e a umiliarli. In questo aiutato da quella che Isaacson definisce deficienza empatica. «Chi non s’impegnava a rendere perfetto il suo prodotto per lui era un imbecille», ricorda un suo dipendente. In Italia, prese in antipatia il direttore generale della Apple perché non rimase impressionato dal suo team né dalla sua strategia di vendita: «Non meriti il privilegio di vendere il Mac» gli disse.
Se la perfezione non esclude la possibilità di raggiungere il successo e di essere inserito, come Jobs, nel pantheon dei grandi innovatori, è comprovato che comportamenti irritanti e abitudini controproducenti interferiscono con la capacità di costruire squadre coese e orientate agli obiettivi. Il team agirà mosso dalla paura o per compiacimento. Il perfezionismo di Jobs ha plasmato il suo stile di leadership e ha creato un ambiente al limite del burnout. Gli aggettivi usati dai suoi dipendenti per descriverlo sono «sprezzante, ostile, dispettoso». Per molti non era «né un capo da imitare, né un uomo modello, né una persona ideale da emulare».
Campo di distorsione della realtà
Sebbene Jobs avesse anche standard personali particolarmente elevati, la sua ossessiva battaglia per la perfezione non gli precluse, come scrive il suo biografo ufficiale, «una vita di alti e bassi». Né lo esentò dalla possibilità di prendere decisioni irragionevoli, di commettere errori e di fallire. I prodotti venivano lanciati dopo la sua approvazione ma i primi Mac erano tutt’altro che perfetti. L’ insuccesso commerciale del Macintosh, lo portò a scontrarsi con il consiglio di amministrazione di Apple. Buttato fuori dalla Apple, sulla via del fallimento con la NeXT, rischiava una terza sconfitta con Pixar.
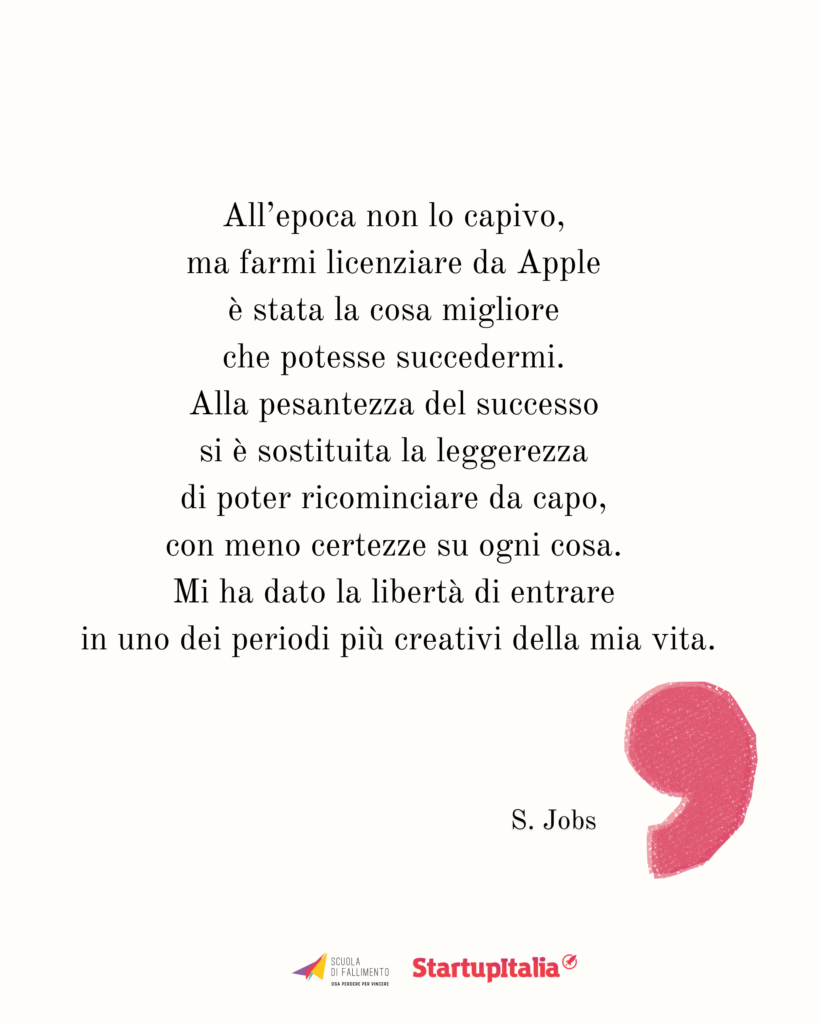
Proprio perché perfezione e successo non è un binomio scontato, il perfezionista ha una paura intrinseca del fallimento. Vuole avere successo in tutto ciò che fa. E talvolta, per raggiungere questo successo, paga un prezzo molto alto per mantenere l’ideale di storia perfetta, ignorando la realtà se questa non si accorda con la propria aspettativa. E Jobs pare fosse molto bravo a raccontare gli eventi dal suo personale punto di vista. I colleghi alla Apple chiamavano campo di distorsione della realtà la sua capacità di piegare la verità trasformando la sua visione in una realtà condivisa, spingendo le persone a fare l’impossibile. In alcuni casi la distorsione era sinonimo di bugia o imbroglio. Un giorno, una sua dipendente, J. Hoffaman, venne a sapere che Jobs aveva modificato le sue proiezioni di marketing «in maniera da distorcere completamente la realtà».
Dopo i primi tre mesi dal lancio del primo Macintosh, le vendite diminuirono. Se l’estetica aveva trascinato gli acquisti del nuovo computer Apple, il tempo rivelò i suoi limiti: era troppo lento, non abbastanza potente, mancava di un disco rigido interno e di ventole che Jobs non amava ma la cui assenza erano all’origine dei guasti ai suoi componenti. I clienti soprannominarono il Macintosh tostapane beige. Non un complimento quindi.
Come più tardi avrebbe lamentato la Hoffman: «Il campo di distorsione della realtà può servire come sprone, ma prima o poi la realtà colpisce». Per ovviare al problema, Jobs lanciò nello stesso anno Macintosh XL. Un nuovo Macintosh migliorato? No, mise sul mercato scorte di Lisa invenduti, il computer che portava il nome della figlia prima rinnegata e poi riconosciuta, dotati di un software di emulazione Macintosh. «Ero furibonda, perché il Macintosh XL non era vero» dice la Hoffman. «Era solo un modo per liberare il magazzino dai Lisa invenduti. Vendette bene ma non potemmo che togliere dal mercato quell’orribile truffa, per cui detti le dimissioni.»

Il perfezionismo è un tratto di personalità ma anche un’abitudine a pretendere da sé e dalle altre persone prestazioni prive di qualsiasi imperfezione. Per celebrare il suo trentesimo compleanno, nel febbraio 1985, Jobs organizzò una festa per un migliaio di invitati al St Francis Hotel di San Francisco. L’invito recitava: «Un vecchio proverbio indù dice che nei primi trent’anni della tua vita ti fai le tue abitudini; nei secondi trent’anni sono le tue abitudini che fanno te. Venite ad aiutarmi a festeggiare le mie».
Jobs non ha mai cambiato le sue abitudini, neanche quando era in ospedale. «Ci domandavamo tutti se sarebbe uscito da questa esperienza con un atteggiamento più gentile, ma scoprimmo che non era così», confida una amica dei Jobs.
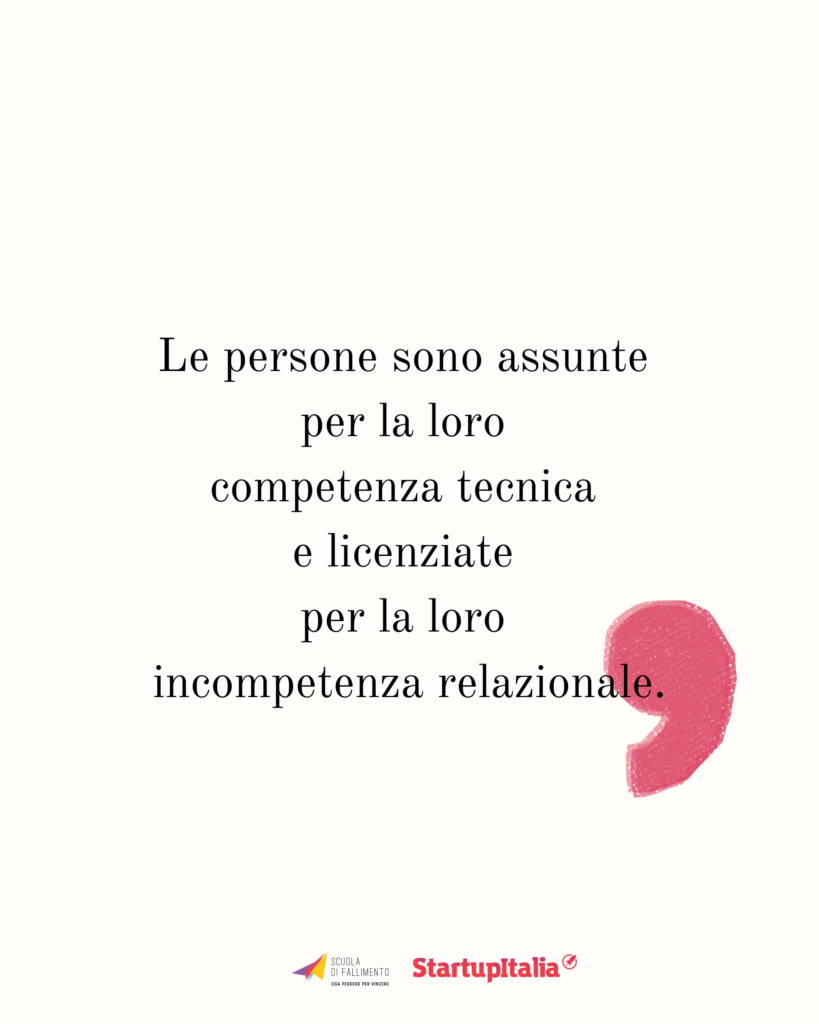
Non abbiamo una controprova che migliorando le sue abitudini le cose sarebbero andate diversamente, ma certamente possiamo condividere il pensiero del suo socio e amico Wozniak:
«Steve avrebbe potuto dare il suo contributo senza terrorizzare tanta gente. Sono contento di essere più paziente e di non avere tutti quei conflitti. Se il progetto Macintosh fosse stato diretto a modo mio, forse si sarebbe incasinato tutto, ma penso che, se la gestione fosse stata un miscuglio del suo stile e del mio, sarebbe stata migliore di quella di Steve». Queste tendenze comportamentali sono uno dei motivi principali per cui le persone in posizioni di autorità falliscono nel proprio ruolo. Si chiama peccato di autorità quell’insieme di comportamenti che sono messi in atto da manager o imprenditori che seppur considerati di successo perché di talento e con carriere brillanti, sono stati licenziati o ricollocati a causa di un atteggiamento arrogante e vessatorio.
Imprenditori e manager brillanti ma non amabili hanno uno stile abrasivo, intimidatorio e distaccato. Deragliano a causa dell’insensibilità verso gli altri e della ruvidità dei modi. Alcuni sono così brillanti da diventare arroganti, intimidendo gli altri con la loro conoscenza. Dopo aver sentito per così tanto tempo quanto sono bravi, alcuni semplicemente perdono l’umiltà. Jobs non perdeva occasione per sottolineare il suo livello di intelligenza e trattava con inferiorità persone come Bill Gates. Considerava Gates inferiore soprattutto in tema di gusti, di stile e di capacità immaginativa. Quelli ambiziosi sono afflitti per la loro ambizione. Alla fine, la scia di persone ferite diventa un cumulo di macerie.
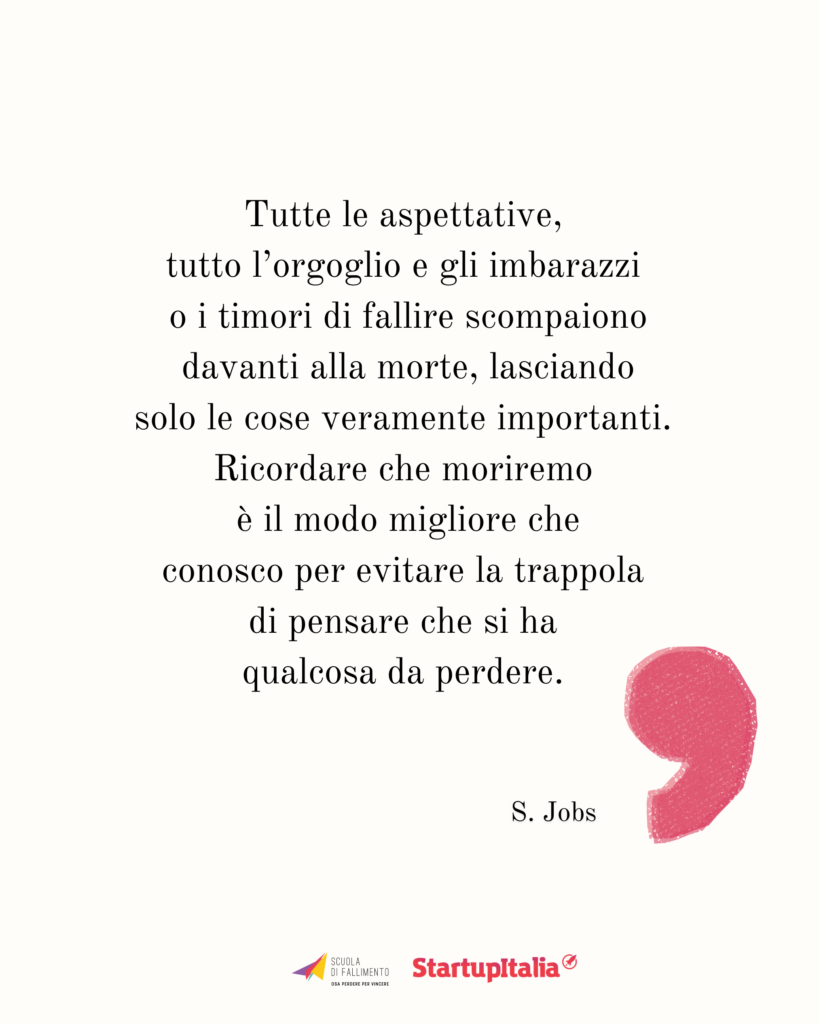
Conoscere i tratti più critici di sé stessi ma anche dei candidati o dei soci può aiutare a prendere decisioni migliori. Se sei una startup, la perfezione è semplicemente troppo costosa perché può portare alla paralisi delle decisioni: a non prendere mai una decisione, non agendo mai, o a prenderla quando è ormai troppo tardi. Il buono abbastanza è un approccio che ha invece molti pregi. Fatto è meglio che perfetto esprime la stessa legge usando una diversa espressione.
Il consiglio quindi è di smussare il vostro grado di perfezione, l’ottimo non è la scelta migliore in un mondo complesso come il nostro e non elimina la possibilità di un inciampo.
Le 3 regole d’oro
Allena la predisposizione all’azione: il perfezionismo è un’arma a doppio taglio, può avere dei vantaggi ma può avere conseguenze negative in termini di inazione e procastinazione (meglio non fare, che fare male). La storia insegna che è meglio prendere una decisione sbagliata che nessuna decisione. La velocità di decisione è, in alcuni casi, più importante dell’immobilità.
Fai tu la legge di Joseph M. Juran: il manager Juran, formulò un principio affine a quello di Pareto secondo il quale le cose davvero importanti (vital few) sono poche, circa il 20% e le cose meno importanti (trivial many) sono molte, il restante 80%. Focalizzati sull’essenziale soprattutto se hai scarsità di denaro e di tempo.
Ricerca il miglioramento continuo: l’ossessione per l’assenza di difetti e di errori è una trappola mentale che impone standard irrealistici. Il perfezionismo è fonte di ansia e di stress, di cattiva gestione delle emozioni e dei fallimenti propri e altrui. Aspirare a fare le cose nel migliore modo possibile è un atteggiamento che favorisce il successo. Ogni scelta anche se imperfetta genera apprendimento e un senso di motivazione per le sfide future.




