L’idea che la felicità segua una curva a U nel corso della vita è stata a lungo un punto fermo nella psicologia del benessere: si raggiunge il picco tra i 20 e i 30 anni, quando si abbraccia l’indipendenza e l’esplorazione. Si sperimenta un calo verso i 40-50 anni, una fase in cui gli individui avvertono molto la pressione sociale produttiva, la necessità di realizzarsi, di comprare la casa, di fare scelte in un mondo sempre più incerto, infine, dopo i 50 anni, la curva risale, portando a una maggiore accettazione della vita e a una diminuzione del carico di responsabilità. Questa visione ha offerto un quadro rassicurante e prevedibile del nostro percorso emotivo.
«La grande maggioranza delle persone preferirebbe un futuro sostenibile e cooperativo, piuttosto che uno competitivo e individualista»
Tuttavia, il mondo sta cambiando rapidamente, e con esso anche le dinamiche della felicità. Recentemente, si osservano segnali che suggeriscono una potenziale alterazione di questa curva consolidata. Lo psicoterapeuta Alberto Pellai, ad esempio, in un recente articolo, ha evidenziato un dato significativo: nell’ultimo decennio, il numero di diciottenni che conseguono la patente di guida si è dimezzato. Questo non è un semplice cambiamento statistico, ma un simbolo eloquente della diminuzione del desiderio di esplorazione e autonomia tra i giovani. Sembra che la spinta verso l’indipendenza, un tempo motore della felicità giovanile, stia perdendo la sua forza.
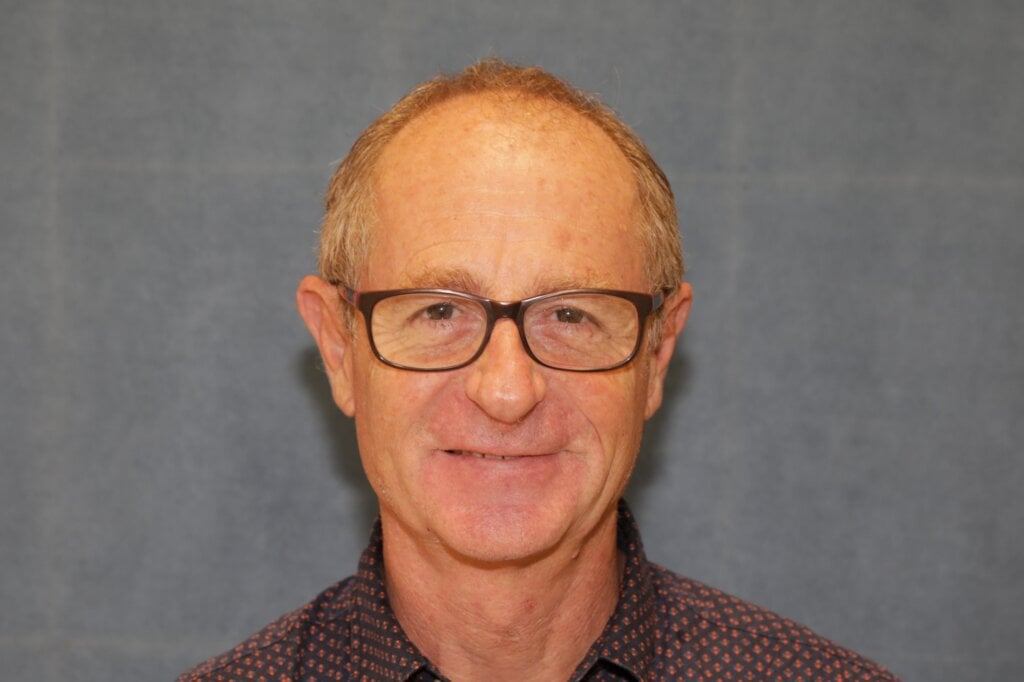
La ricerca della felicità
Parallelamente, l’ombra della genitorialità controllante si allunga su questa generazione. Un eccesso di cura e controllo, seppur mosso dalle migliori intenzioni, sembra aver contribuito a forgiare giovani più ansiosi e meno inclini a navigare le sfide del mondo reale. Questa realtà solleva un interrogativo cruciale: se i giovani sono sempre più immersi nel virtuale e meno nel reale, e se un senso di impotenza li pervade di fronte a un futuro percepito senza aspettative, la celebre curva a U rischia di appiattirsi, trasformandosi in una linea retta. «I giovani subiscono molta più pressione oggi rispetto al passato, dalla scuola, poco tempo per la socialità, molto screen time, è una generazione con molte più ansie e senso di impotenza», afferma il Prof. Stefano Bartolini, docente di Economia della Felicità all’Università di Siena. Siamo di fronte a una generazione che potrebbe non sperimentare quel picco di felicità giovanile, né la successiva risalita, intrappolata in un limbo di ansia e disillusione? È giusta la percezione collettiva d’impotenza al cambiamento o è illusione?

Professor Bartolini, oggi si parla molto di polarizzazione e frammentazione nelle società occidentali. Ma è davvero così?
In parte sì, ma c’è un dato sorprendente che spesso sfugge: su alcune questioni fondamentali, come il tipo di società in cui vorremmo vivere, esiste un consenso amplissimo. Una ricerca internazionale diretta da Andreas Krafft, condotta in sette paesi occidentali, mostra che la grande maggioranza delle persone preferirebbe uno scenario futuro sostenibile e cooperativo, piuttosto che uno competitivo e individualista.
Che cosa si intende, concretamente, per “scenario sostenibile”?
È una società che dà priorità alla cooperazione, alla famiglia, all’equità nella distribuzione della ricchezza e alla sufficienza economica, rispetto alla corsa alla produttività e alla competizione internazionale. In Italia, ad esempio, oltre il 96% degli intervistati ha indicato questa visione come quella desiderabile per il 2040.
«Sappiamo dove vorremmo andare, ma siamo convinti che non ci arriveremo»
E allora perché non ci stiamo muovendo in quella direzione, se il consenso è così ampio?
Perché prevale una sensazione di impotenza collettiva. Molti pensano che, pur desiderando un cambiamento, non ci sia la possibilità concreta di realizzarlo. In altre parole: sappiamo dove vorremmo andare, ma siamo convinti che non ci arriveremo.
Questa percezione di impotenza da dove nasce?
Una delle cause principali è la profonda crisi di fiducia nei confronti della politica, che rappresenta il principale strumento di azione collettiva istituzionalizzata. Ma c’è anche un altro meccanismo molto potente: le persone sottovalutano quanto le loro opinioni siano condivise.
«Le persone sottovalutano quanto le loro opinioni siano condivise»

Può farci un esempio concreto?
Certo. Un sondaggio in 125 paesi ha mostrato che l’89% delle persone vorrebbe che i propri governi facessero di più per combattere il cambiamento climatico. Ma quando si chiede loro quanti altri siano disposti a fare sacrifici, come donare l’1% del reddito, stimano che solo il 43% lo farebbe. Questo divario tra ciò che si pensa e ciò che si immagina pensino gli altri alimenta un malinteso senso di solitudine.
E se le persone scoprissero di non essere sole, che cosa accadrebbe?
Lo mostra chiaramente un esperimento americano costituito da due fasi distinte. Nella prima a ciascuno dei componenti di un campione di persone sono stati dati 450 dollari. Ad ognuno è stato chiesto di decidere quanto di tale somma dare a un ente benefico che riduce le emissioni di carbonio e quanto tenere per sé. In media, le persone hanno donato circa la metà del denaro e hanno tenuto il resto. Gli è stato inoltre chiesto di stimare la percentuale dei propri concittadini che ritengono necessario un maggior impegno contro il cambiamento climatico. La stima media espressa dal campione è stata pari al 61%. Un valore ampiamento sottostimato visto che la vera percentuale era il 79%.
«C’è una maggioranza silenziosa che desidera un mondo più equo, più umano e più sostenibile»

E la seconda parte dell’esperimento cosa ha evidenziato?
La seconda fase dell’esperimento, del tutto identica alla prima tranne un particolare: i partecipanti sono stati preventivamente informati della vera percentuale di concittadini che vogliono più impegno contro il cambiamento climatico. In seguito a questa informazione sono aumentati in media di 16 dollari le donazioni agli enti benefici che riducono le emissioni di carbonio. In altre parole, essere informati sulla vastità del sostegno alle politiche climatiche ha avuto un sostanziale effetto di propulsione di tale sostegno.
Questo meccanismo vale solo per il cambiamento climatico?
Assolutamente no. Vale per qualunque questione collettiva in cui le persone sono “cooperatori condizionali”, cioè disposte a fare la propria parte se vedono che anche gli altri lo fanno. Il problema è che molti pensano di essere in minoranza, e questo frena la partecipazione. Ma non è vero: c’è una maggioranza silenziosa che desidera un mondo più equo, più umano e più sostenibile.
Quindi lei sostiene che il sistema attuale, per quanto dominante, è fragile?
Sì, è più fragile di quanto sembri. È sostenuto da una convinzione sbagliata: quella di essere soli. Ma se quel filo sottile si spezza, le proteste di Gaza sono un esempio, o quello che vediamo negli Stati Uniti con le proteste contro ICE, la spirale del silenzio può trasformarsi in una spirale di rumore. La rassegnazione può essere trasformata in una forza di cambiamento straordinaria.
In sintesi, qual è la sua conclusione?
Che un cambiamento radicale è possibile, e che potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo. Ma tutto dipende dalla consapevolezza collettiva: dobbiamo renderci conto di essere in tanti a volere un futuro diverso. Quando questo accadrà, il sistema attuale non potrà più reggere.



