Da sempre gli eserciti studiano come utilizzare le simulazioni per educare i propri ufficiali e soldati. La nuova guerra virtuale ha generato non solo nuovi metodi di violenza tra nazioni, ma anche nuove relazioni tra le sfere civili e militari.
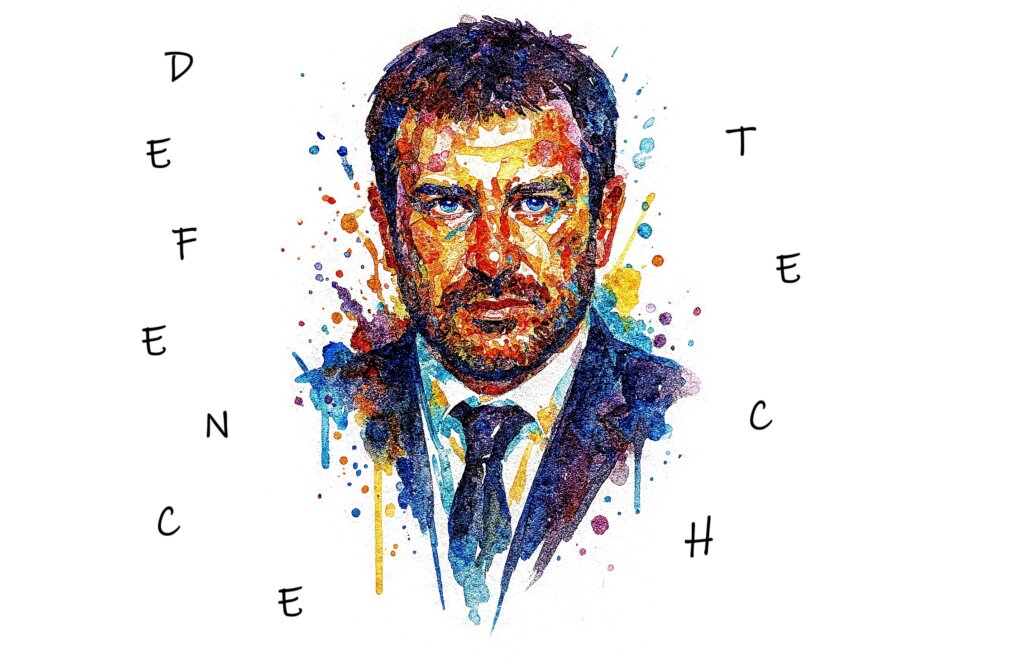
Tutto iniziò con Doom
Nel 1997, ad esempio, i Marines iniziarono a utilizzare modifiche di giochi commerciali per addestrare i soldati di fanteria. Il primo di questi fu Marine Doom, una modifica del popolare sparatutto in prima persona. L’esercito statunitense fece uso di Tom Clancy’s Rogue Spear. La Marina commissionò lo sviluppo di Fleet Command e l’esercito britannico iniziò a usare Half-Life.
Cos’è il militainment
Avvenne anche l’opposto: i giochi sviluppati in ambito militare divennero commerciali per uso civile. Nel 1994, i sistemi di gioco Sega convinsero l’appaltatore militare Martin Marietta a rilasciare commercialmente un simulatore usato per addestrare gli operatori di carri armati. Il risultato fu il gioco Desert Tank.

L’anno successivo, l’azienda di videogiochi Digital Integration cercò di rilasciare un altro simulatore di addestramento, questa volta sviluppato dall’appaltatore militare McDonnell Douglas per il volo degli elicotteri Apache. Il gioco arrivò sul mercato nel 1995 con il nome di Apache Longbow. La prima guerra del Golfo aveva trasformato l’Apache in una star televisiva, e naturalmente il pubblico era ansioso di metterci le mani sopra.
È in questo contesto che nasce, nel 1999, il franchise di videogiochi America’s Army. Un soldato visionario, il colonnello Casey Wardynski, decise di creare un’esperienza virtuale da soldato per coinvolgere il pubblico e favorire il reclutamento. Lanciato nel 2002, il gioco mirava ad attrarre un pubblico più giovane e a contrastare il calo delle iscrizioni. La serie, gratuita e basata sul motore grafico Unreal Engine utilizzato anche in contesti reali, fungeva da strumento di marketing per informare il pubblico sulla vita militare e sui protocolli, offrendo al contempo un’esperienza multiplayer a squadre accattivante, simile a Counter-Strike.
Il progetto fu un successo commerciale, creando un legame diretto tra l’esercito e i videogiocatori. Il suo impatto sul reclutamento e sulla percezione pubblica dell’esercito fu significativo. Da allora è stato un successo travolgente, con 6 milioni di utenti registrati nel 2005. America’s Army introdusse un tipo del tutto nuovo di rapporto tra i militari e la cultura popolare.
Non si trattava di un semplice videogioco di guerra: America’s Army portava con sé un sigillo di autenticità. La sola esistenza del gioco rafforzava l’idea che la guerra potesse diventare una forma di intrattenimento, un’attività per il tempo libero.
Questa percezione fu ulteriormente rafforzata quando l’Esercito rilasciò una versione del gioco chiamata Real Heroes, in cui i personaggi giocabili erano basati su veri soldati che avevano prestato servizio in Iraq e in altri scenari. L’iniziativa Real Heroes fu accompagnata anche dal lancio di action figure in plastica raffiguranti quegli stessi soldati. Con America’s Army, l’esercito aveva effettivamente conquistato una nuova frontiera.
Il concetto di militainment, e lo sviluppo di videogiochi a sfondo propagandistico (identificare il “cattivo” con una nazione o una religione), permise al Pentagono di ottenere due successi. Prima di tutto un elevato numero di arruolamenti, in secondo luogo la capacità di diffondere best practice sin dall’inizio: fare pre-addestramento (nozioni di base di addestramento, linguaggio di guerra etc.) risparmiando sul tempo di ingaggio delle reclute.
Non solo negli USA
Se la visione di addestramento e propaganda è iniziata in USA non si è fermata in Occidente. Il programma americano è divenuto un progetto di riferimento per ogni nazione che vuole digitalizzare i propri cittadini e trovare nuovi metodi per arruolare soldati. Nel 2022, secondo Writersblocklive circa 3,2 miliardi di persone nel mondo giocavano ai videogiochi, a testimonianza della portata globale di questo fenomeno culturale.

Di particolare rilievo è il fatto che il Sud globale rappresenta oltre il 50% del mercato globale degli utenti, evidenziando un cambiamento significativo nei centri di consumo e produzione culturale. Dei 3,2 miliardi di videogiocatori nel mondo, circa 1,47 miliardi si trovano in Asia, confermandola come il principale mercato regionale. Seguono l’Europa con 715 milioni di giocatori, l’America Latina con 419 milioni, e il Nord America con 284 milioni.
La regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa) conta 168 milioni di giocatori, mentre l’Africa subsahariana ne registra 143 milioni. Infine, in Oceania si contano 32 milioni di utenti. Questi numeri mostrano chiaramente che il videogioco è oggi un linguaggio globale, che coinvolge ogni parte del mondo e riflette trasformazioni profonde nei consumi culturali e tecnologici. La centralità del Sud globale in questo scenario rappresenta una nuova dinamica, sia economica che culturale, che merita attenzione. I videogiochi, specialmente quelli che si possono giocare online, senza costi eccessivi e hardware più modesti, sono ubiqui.
Negli ultimi anni ai videogiochi FPS si sono aggiunti simulatori aerei-spaziali. Una variabile che richiede, al giocatore, una maggiore concezione spaziale: su, giù, destra, sinistra. Mentre gli FPS implicano un territorio a tre dimensioni, ma pur sempre legato alla terra, quelli spaziali e aerei implicano una maggiore cognizione dello spazio che può essere utilizzato. Con il crescere di queste simulazioni ibride (o dual-use, sia per militari che civili) è andato crescendo il fenomeno dei droni. Nati come fenomeno militare a partire dai primi anni della Seconda guerra mondiale, i droni attuali sono economici, ad uso civile e facilmente militarizzabili.
L’Ucraina e le guerre sintetiche
Il concetto di guerra combattuta in maggioranza da “soldati non viventi” è familiare al mondo della fantascienza. Tuttavia le tecnologie moderne, combinate con una crescita estrema del mondo digitale, hanno permesso al mondo dei droni civili (ad ala fissa o a multielica verticale) di divenire un prodotto ubiquo e dispiegabile in ogni scenario bellico. Negli ultimi tre anni di guerra i droni sono divenuti i killer più letali negli scenari di guerra.
Le stime parlano, nell’ultimo anno, di circa il 60-70% di soldati ucraini e russi uccisi da sintetici, pilotati da umani a distanza di alcuni chilometri. Mentre i droni dell’era delle guerre di Bush (comunemente note come guerre al terrore dai media occidentali) vedevano il dispiegamento di grandi droni ad ala fissa per ricognizione e bombardamenti, il nuovo campo di battaglia ha visto una rapida evoluzione di piccoli droni, relativamente economici.
Lezioni di droni (a scuola)
Oggi nelle scuole ucraine e russe sono numerosi i bambini che possono sperimentare videogiochi basati sulla simulazione aerea di droni. Ci sono anche videogiochi commerciali usciti di recente come Drone Sector di Microprose e Firehawk FPV. In Russia i giovani sono invitati a prendere lezioni di pilotaggio di droni, come riporta il Guardian. In Ucraina si sono spinti anche più avanti integrando formazione e addestramento ai giovani studenti minorenni sia per quanto concerne l’utilizzo di sintetici in remoto, come i droni aerei, che addestramento ad armi da fuoco.
Propaganda militare di successo?
Se queste modalità di propaganda militare sono in continua crescita è da comprendere quanto possano avere successo. Il caso americano dimostra che, se ben strutturate, queste iniziative possono aumentare l’arruolamento e, in generale, spostare una parte dell’opinione pubblica polarizzandola verso un modello cognitivo semplice e binario: nemico/amico.

Ma per comprendere meglio il percorso psicologico del militainment, alla base di queste strategie, si deve accennare al concetto di capitalismo limbico che è cresciuto in tempi brevissimi grazie all’espansione del mondo digitale che può dispiegare ogni soluzione e contenuto in modo pressoché immediato in ogni parte del mondo (salvo censure da parte degli stati nazionali).
La chiave? La dopamina
L’evoluzione occidentale di Internet – e in seguito nel resto del mondo – favorisce comportamenti compulsivi e ossessivi, anche proponendo azioni e stimoli che altrimenti non ci sarebbero mai capitati. I video non diventano solo “virali” in senso figurato: sono letteralmente contagiosi. Le persone povere o con basso livello di istruzione sono particolarmente vulnerabili all’iperconsumo a causa dell’accesso facilitato a ricompense immediate, in un contesto socio-economico segnato da carenze abitative, istruzione di bassa qualità e scarsa accessibilità alle cure sanitarie. A questo fattore di guerra cognitiva si deve integrare una serie di altre variabili.
Viviamo in un’epoca di accesso senza precedenti a stimoli ad alto impatto dopaminergico, come droghe, cibo, notizie, gioco d’azzardo, shopping, videogiochi, messaggi, sexting, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. In questo panorama, i videogiochi rappresentano un caso emblematico, grazie al loro meccanismo di ricompensa continua, che li rende altamente suscettibili alla dipendenza. Il meccanismo della creazione della dopamina, un neurotrasmettitore, è già stato spiegato da autori come Lustig, nel suo libro più famoso The Hacking of the American Mind: The Science Behind the Corporate Takeover of Our Bodies and Brains.
Robert Lustig denuncia come la ricerca della felicità sia stata compromessa da una cultura della dipendenza e della depressione, alimentata da stimoli dopaminici eccessivi (come zucchero, social media, pornografia, contenuti violenti) e dallo stress cronico della vita moderna. Spiega come la dopamina, che spinge al desiderio, possa sopraffare la serotonina, legata alla soddisfazione, generando così dipendenze e infelicità. Nell’ambito digitale il gaming è un generatore di dopamina. Quante volte, se siete un gamer, avete gioito nell’eliminare un avversario, nel conquistare una città o abbattere un’astronave. Trasportare queste sensazioni in un ambiente reale, dove non si è più comandante di una nave spaziale ma di un asset reale, come un drone kamikaze, è un passaggio ormai quasi indistinguibile dalla realtà.
Avere già oggi soldati remoti, piloti di droni, è piuttosto facile. Possiamo osservare il fenomeno sui fronti russo e ucraino, ma per elevare questi soldati e renderli parte integrante di un esercito, o di un corpo d’armata (marina, esercito, spaziali, remoti, cyber, etc…), serviranno alcuni adattamenti psicologici le cui leve sono già oggi disponibili.

Fattori generanti dopamina per creare dipendenza del soggetto verso una specifica attività (in questo caso pilotare e colpire bersagli in remoto). Alterare o manipolare i valori etici, già oggi sempre più incrinati da contenuti violenti sia virtuali che nella vita quotidiana. Incutere un maggior timore del nemico (vero o percepito) tramite una rielaborazione del contesto cognitivo del soggetto e della massa popolare in cui è inserito tramite una guerra cognitiva che alteri ogni punto di riferimento del soggetto saturando la sua sfera cognitiva.
L’attività di propaganda dei media occidentali, specialmente quelli finanziati da USAID quando era gestita da Biden, è un esempio. In ultimo serve una crescente ignoranza cognitiva dove il soggetto, già corrotto dai fattori precedenti, riduce volontariamente la sua esposizione alla cornucopia di informazioni disponibili tramite la rete, perdendo via via capacità di discriminare le fonti e fidandosi di poche fonti che ritiene credibili.
Con questi quattro elementi creare soldati remoti senza senso etico nativo, ma plasmabili e con una formazione tecnica sufficiente per utilizzare asset remoti è facile. E sta già accadendo oggi. Le guerre sintetiche saranno sempre più diffuse. L’Ucraina ha aperto un vaso di Pandora che non sarà più richiuso e ciò che osserviamo oggi nel conflitto è solo l’inizio. Giocando (coi droni) si impara (a uccidere) in modo più efficiente.




