Quali sfide attendono la società di domani? Quali sono i rischi e quali le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico? Per la rubrica “Futuro da sfogliare” un estratto del libro Fisica esistenziale di Sabine Hossenfelder, edito da Apogeo.
***
Dopo aver saputo che sono un fisico, un giovane mi chiese: “Posso domandarle una cosa?”. “Riguarda la meccanica quantistica”, aggiunse timidamente. Ero pronta a discutere il postulato sulle misurazioni e le insidie dell’entanglement, ma non ero preparata alla domanda che seguì: “Uno sciamano mi ha detto che mia nonna è ancora viva, grazie alla meccanica quantistica. Solamente qui e ora non è viva. È vero?”. Come potete immaginare, ci sto ancora pensando. La risposta breve è che l’affermazione stravagante dello sciamano non è del tutto sbagliata. La risposta lunga seguirà nel Capitolo 1, ma prima di arrivare alla meccanica quantistica delle nonne defunte, voglio spiegarvi perché ho scritto questo libro.
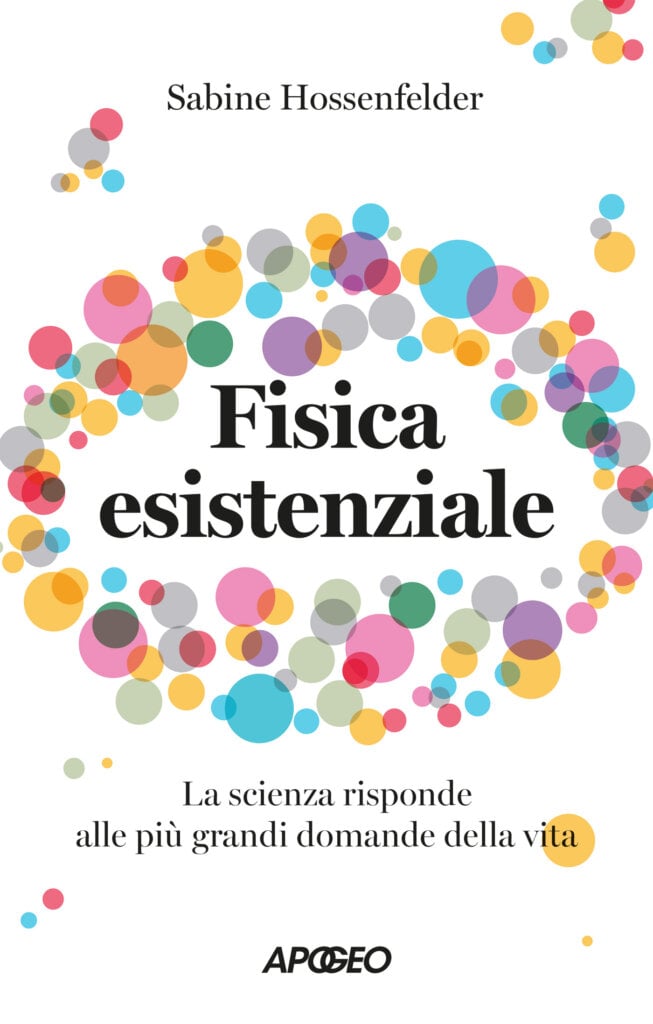
In oltre dieci anni di attività di sensibilizzazione del pubblico, ho notato che i fisici sono bravissimi a rispondere alle domande, ma pessimi a spiegare perché a qualcuno dovrebbero interessare le loro risposte. In alcune aree della ricerca scientifica, sovente lo scopo di uno studio è, alla fine, un prodotto commerciale. Ma nel caso dei fondamenti della fisica, dove svolgo la maggior parte della mia ricerca, il prodotto principale è la conoscenza. Troppo spesso, però, io e i miei colleghi presentiamo questa conoscenza in un modo così astratto che nessuno capisce perché l’abbiamo cercata. Non che questo sia specifico solo della fisica.

Il divario tra gli esperti e i non addetti ai lavori è così diffuso, che il sociologo Steve Fuller sostiene che gli accademici utilizzano una terminologia incomprensibile per custodire gelosamente le loro conoscenze, con lo scopo di renderle più preziose. Come ha denunciato il giornalista americano e vincitore del premio Pulitzer Nicholas Kristof, gli accademici codificano “le intuizioni in una prosa turgida” e “come doppia protezione contro il consumo pubblico, questo gergo viene talvolta nascosto in riviste specialistiche, oscure a molti”.
Alle persone non interessa molto se la meccanica quantistica è prevedibile: vogliono sapere se il loro stesso comportamento è prevedibile. Non importa se i buchi neri distruggono o meno le informazioni: vogliono conoscere cosa succederà alle informazioni raccolte dalla civiltà umana. Non importa neanche se i filamenti galattici assomigliano a delle reti neuronali: vogliono sapere se l’universo è in grado di pensare. Le persone sono persone. Chi l’avrebbe mai detto?
Naturalmente, anch’io voglio sapere queste cose. Ma nel mio percorso accademico ho imparato a evitare di pormi queste domande, per non parlare delle risposte. Dopo tutto, sono solo un fisico. Non sono in grado di parlare di coscienza, di comportamento umano e così via. Tuttavia, la domanda di quel giovane mi ha fatto capire che i fisici sanno alcune cose, se non sulla coscienza in sé, almeno sulle leggi fisiche che ogni cosa nell’universo (compresi voi, io e vostra nonna) deve rispettare.
Non tutte le idee sulla vita, sulla morte e sull’origine dell’esistenza umana sono compatibili con le basi della fisica. È una conoscenza che non dovremmo nascondere in riviste oscure, con una prosa incomprensibile. Non solo vale la pena di condividere queste conoscenze, ma tenerle solo per noi ha delle conseguenze.

Se i fisici non si fanno avanti e non spiegano cosa dice la fisica sulla condizione umana, altri coglieranno l’occasione e abuseranno della nostra terminologia criptica per promuovere la pseudoscienza.
Non è una coincidenza che l’entanglement quantistico e l’energia del vuoto siano le spiegazioni preferite dai guaritori alternativi, dagli spirituali e dai venditori di olio di serpente. A meno che non si abbia un dottorato di ricerca in fisica, è difficile distinguere il nostro linguaggio da quello dei ciarlatani. Tuttavia, il mio scopo non è solo quello di smascherare la pseudoscienza per quello che è. Voglio anche far capire che alcune idee “spirituali” sono perfettamente compatibili con la fisica moderna e che altre sono addirittura supportate da essa. E perché no?
Che la fisica abbia qualcosa da dire sul nostro legame con l’universo non è poi così sorprendente. Scienza e religione hanno le stesse radici e ancora oggi affrontano alcune delle stesse domande: da dove veniamo? Dove andiamo? Quanto possiamo conoscere? Riguardo a questi interrogativi, i fisici hanno imparato molto nell’ultimo secolo. I loro progressi dimostrano che i limiti della scienza non sono fissati, ma si spostano in avanti man mano che impariamo a conoscere il mondo. Di conseguenza, oggi sappiamo che alcune spiegazioni basate sulle credenze, che un tempo ci aiutavano a dare conforto e un senso alla vita, sono semplicemente sbagliate.
L’idea, per esempio, che certi oggetti siano vivi perché sono dotati di una sostanza speciale (lo “slancio vitale” di Henri Bergson) era del tutto compatibile con la conoscenza scientifica di duecento anni fa. Ma ora non lo è più. Oggi, con la fisica moderna, abbiamo a che fare con le leggi della natura che operano al livello più fondamentale. Anche in questo caso, le conoscenze acquisite negli ultimi cento anni stanno sostituendo le vecchie spiegazioni basate sulle credenze. Una di queste spiegazioni obsolete è l’idea che la coscienza richieda qualcosa di più dell’interazione di molte particelle, una sorta di polvere magica che conferisce a certi oggetti delle proprietà speciali.

Come per lo “slancio vitale”, si tratta di un’idea superata e inutile, che non spiega nulla. Ne parlerò più approfonditamente nel Capitolo 4 e nel Capitolo 6 discuterò le conseguenze che questo ha sull’esistenza del libero arbitrio. Un’altra idea pronta per essere mandata in pensione è la convinzione che il nostro universo sia particolarmente adatto alla presenza della vita; sarà il tema del Capitolo 7.
Al tempo stesso, prendere coscienza del campo di azione della ricerca scientifica non distrugge solo le illusioni: ci aiuta anche a riconoscere quali credenze sono ancora compatibili con i fatti scientifici. Tali credenze non dovrebbero essere definite “non scientifiche”, ma piuttosto “ascientifiche”, come ha giustamente osservato Tim Palmer (che incontreremo più avanti): la scienza non dice nulla al riguardo. Una di queste credenze è l’origine del nostro universo. Non solo non siamo ancora in grado di spiegarla, ma ci si chiede anche se saremo mai in grado di farlo. Potrebbe essere uno dei temi su cui la scienza è fondamentalmente limitata. Almeno questo è ciò che credo attualmente.
L’idea che l’universo stesso sia cosciente, ho scoperto con sorpresa, è difficile da escludere del tutto (Capitolo 8). E non si sa ancora se il comportamento umano sia prevedibile o meno (Capitolo 9). In breve, questo è un libro sulle grandi questioni che la fisica moderna solleva, dalla domanda se il momento presente differisce dal passato, all’idea che ogni particella elementare possa contenere un unicum, alla preoccupazione che le leggi della natura determinino le nostre decisioni. Naturalmente non posso offrire delle risposte definitive. Ma voglio raccontarvi cosa gli scienziati hanno capito fino ad oggi e anche dove la scienza sconfina nella mera speculazione. Mi atterrò per lo più a teorie della natura consolidate e supportate da prove.

Tutto ciò che dirò, quindi, dovrebbe essere accompagnato dal preambolo “per quanto ne sappiamo attualmente”, il che significa che gli ulteriori progressi scientifici che arriveranno potrebbero implicare una revisione di ciò che leggerete. In alcuni casi, la risposta a un quesito dipende da alcune proprietà delle leggi naturali che non abbiamo ancora compreso appieno, come la misurazione quantistica o la natura delle singolarità spaziotemporali.
In questi casi, farò un accenno a come la ricerca futura potrebbe aiutare a rispondere a quella domanda. Poiché non voglio che ascoltiate solo la mia opinione, ho aggiunto alcune interviste. Alla fine del libro troverete anche un breve glossario con le definizioni dei termini tecnici più importanti. Fisica esistenziale è per coloro che non hanno smesso di porsi grandi domande e non hanno paura delle risposte.



