Quali sfide attendono la società di domani? Quali sono i rischi e quali le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico? Per la rubrica “Futuro da sfogliare” un estratto del libro Il nuovo nucleare di Antonio Ereditato e Stefano Buono, edito da Egea.
***
Quando nei libri e nei film di fantascienza degli anni Cinquanta dello scorso secolo si immaginava il 2000 lo si faceva con una certa ingenuità, estrapolando in maniera incrementale le conoscenze scientifico-tecnologiche dell’epoca: giganteschi computer, grandi missili che sfrecciano per il sistema solare, vestiti di plastica, cibi liofilizzati e chi più ne ha più ne metta. Ma niente Internet, intelligenza artificiale, ingegneria genetica e telefonini. Non per niente, questi sviluppi hanno rappresentato rivoluzioni completamente inattese e game changing, certamente non frutto di uno sviluppo incrementale o altrimenti prevedibile. Oggi, decenni dopo, possiamo giocare lo stesso gioco, già sapendo però che le prossime sconosciute rivoluzioni ci faranno ancora una volta sbagliare largamente le previsioni. Per questo motivo è saggio limitarsi a proiettare le nostre conoscenze verso un orizzonte «prossimo», lontano al massimo un quarto di secolo. Ciononostante, poiché l’attuale progresso della scienza e della tecnologia è esponenziale, i venticinque anni a venire porteranno verosimilmente molti più risultati inattesi di quanto lo abbiano fatto i venticinque anni passati, pur sempre nella speranza di non dover vivere guerre globali o cataclismi di vario genere che possano rallentare il progresso.
Per immaginare il mondo del 2050 dobbiamo obbligatoriamente capire quale sarà l’evoluzione della crisi climatica, purtroppo, un compagno di strada dell’umanità per svariati decenni a venire. Conseguentemente, dovremo prevedere quali strategie saranno state attuate per la decarbonizzazione, a loro volta legate a stretto filo con l’energia che sarà allora disponibile. La crisi climatica costituirà quindi un driver per gran parte delle attività umane, a tutti i livelli. I paesi maggiormente industrializzati avranno dovuto mettere in atto strategie globali e condivise per dimezzare le immissioni di CO2 nell’atmosfera entro il 2030, per arrivare alla neutralità nel 2050 e aiutare finanziariamente i paesi in via di sviluppo. E, ripetiamo, l’energia sarà il principale strumento per la soluzione della crisi, così come ne è stata la causa principale.
A questo proposito, per la metà di questo secolo la fusione nucleare sarà stata ottenuta e le prime centrali di prova saranno già operative, anche se un loro pieno utilizzo commerciale si realizzerà solo verso la fine del secolo. Petrolio e gas verranno ancora utilizzati nei prossimi decenni, ma in maniera preponderante solo nei paesi in via di industrializzazione, mentre il solare fotovoltaico sarà divenuto molto comune e diffuso ovunque, assieme all’eolico e all’idrogeno, grazie a nuove generazioni di dispositivi basati sugli sviluppi della scienza dei materiali. Ma la reale innovazione sarà costituita dalla fissione sicura e pulita della quale abbiamo ampiamente parlato. È prevedibile che il «nuovo nucleare» costituirà non soltanto una componente sostanziosa del portafoglio energetico 5.0 mondiale, ma che i suoi sottoprodotti e le varie applicazioni riempiranno utilmente la nostra vita in maniera sicura, affidabile ed economica.
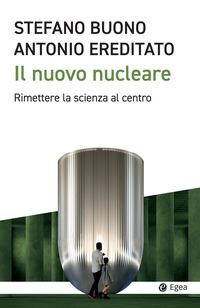
[…] La vera complessità di una centrale nucleare è essenzialmente relativa a ciò che sta fuori dal reattore propriamente detto. Una complessità determinata dalla richiesta di avere un impianto sicuro, efficiente e affidabile, capace di funzionare per circa cento anni e che quindi, deve essere rifornito di carburante «fresco» periodicamente, diciamo ogni cinque-dieci anni. Abbiamo già osservato che il combustibile usato, ancora radioattivo, deve essere accuratamente rimosso, trasportato e stoccato in particolari contenitori per periodi anche molto lunghi. Un discorso simile vale per il combustibile di ricambio, che richiede sistemi complicati e costosi per la gestione e la logistica, che possono incidere fino al 10-20 per cento sul costo dell’energia prodotta, in particolar modo per reattori mobili, da usare per esempio a bordo di una portaerei o di sottomarini. Tale complessità, accettabile per scopi militari, ne renderebbe poco conveniente l’uso per il trasporto civile o per altre applicazioni su piccola e media scala. L’ideale sarebbe allora avere un sistema standardizzato, semplice, compatto e trasportabile con facilità e sicurezza che venga usato e poi dismesso, senza necessità di alcuna ricarica, e come tale operativo per un periodo relativamente breve di dieci-quindici anni. Una specie di mega batteria nucleare, ma di grande potenza.

Se riflettiamo sulla rivoluzione degli SMR (small modular reactors, ovvero piccoli reattori modulari, ndr), ritroviamo la stessa situazione di quando, negli anni Settanta, abbiamo vissuto la fine dei grandi computer mainframe: sempre più potenti e di maggiori dimensioni, finché arrivarono il piccolo microprocessore e i personal computer che portarono al concetto di potenza di calcolo distribuita tra molte piccole unità. Oggi potremmo essere vicini a un cambio di paradigma simile per l’energia nucleare: la nuova generazione di SMR, reattori relativamente piccoli ed economici costruiti in serie, progettati per un funzionamento molto locale, sicuro e semplificato. In realtà, le prospettive sono perfino migliori: l’idea di progettare versioni ancora più semplificate di SMR per i quali si abbandona l’idea del «rifornimento» del reattore, realizzando di fatto delle mega batterie nucleari, sta divenendo realistica. Questi sistemi potrebbero fornire calore per i processi industriali o elettricità per un quartiere di una grande città, funzionare per due o tre lustri e poi essere trasportati alla fabbrica che li ha prodotti (in serie) per il rifornimento di carburante e la rigenerazione.
Gli SMR, infatti, sono progettati per potenze di poche centinaia di MWe, certo molto più piccoli dei reattori di terza generazione, ma comunque richiedono un assemblaggio in fabbrica e un’opportuna installazione sul sito di operazione. Le batterie a reattore, invece, avranno una potenza molto contenuta, fino a circa 40-50 MWe – sufficiente per fornire energia a più di trentamila appartamenti –, tale da configurare una notevole semplicità costruttiva: una catena di montaggio semplice per un contenitore esterno del reattore convenzionale e di dimensioni contenute, in alcuni casi capace di entrare in un container per la sua logistica. Inoltre, il calore accessorio verrebbe usato per il riscaldamento delle abitazioni. I vantaggi economici di un simile approccio sono evidenti. Una batteria da 40 MWe potrebbe costare a regime 150-250 milioni di euro: questo equivale al consumo di combustibile di alcuni anni di una grossa nave commerciale che ha bisogno di tale potenza. L’investimento si ripagherebbe velocemente anche per l’assenza dei rifornimenti, per la possibilità di trasportare più merce – grazie all’assenza dei serbatoi e del peso del combustibile – e in meno tempo. Il discorso è analogo per comunità economicamente e logisticamente sfavorite, e non connesse alle grandi reti di distribuzione, quali zone minerarie o isole. Inoltre, l’installazione delle batterie a reattore non prevede i complessi cantieri che hanno costituito in passato ragguardevoli problemi ai reattori tradizionali – in alcuni casi imprevisibili –, con notevoli aggravi rispetto alle stime finanziarie iniziali. La batteria a reattore, invece, viene realizzata e installata rapidamente e diventa una sorgente di energia a richiesta, come una normale batteria elettrica; un prodotto come un altro, non una grande infrastruttura: proprio come un personal computer rispetto a un grande mainframe.
Anche dal punto di vista ambientale una batteria nucleare avrebbe un’«impronta» ridottissima rispetto a quella di un impianto eolico o fotovoltaico, a parità di potenza erogata.

I numeri che associano povertà al bisogno di energia sono impressionanti: è necessario fornire almeno 1000 kilowattora di energia annui per fare uscire una persona dalla povertà, confrontati ai circa 3000 consumati nei Paesi più ricchi. Questo impone, per un’umanità prossima futura di quasi dieci miliardi di persone, la disponibilità di circa 30-40mila miliardi di kilowattora, in più neutri dal punto di vista climatico, rendendo l’uso del nucleare o delle batterie nucleari a reattore un ingrediente essenziale per la soluzione del problema. Insomma, la combinazione di SMR e batterie costituirà sicuramente una strategia vincente verso la democratizzazione della distribuzione di energia verde per i decenni a venire.
Infine, per quanto riguarda la questione della sicurezza e di come questa viene percepita dall’opinione pubblica, le batterie a reattore sono dispositivi estremamente robusti per costruzione, uno dei loro punti di forza. Le dimensioni ridotte contribuiscono a quest’aspetto. In primo luogo, la quantità di calore residuo che va rimossa quando il reattore viene spento è contenuta. Inoltre, il nocciolo ha un volume piccolo rispetto alla sua superficie, rendendo termicamente più semplice raffreddarlo senza alcun intervento esterno. Il sistema è essenzialmente in equilibrio ed è autoregolante. Il reattore, poi, è dotato di una struttura di contenimento in acciaio compatta e resistente che lo circonda completamente, impedendo in maniera passiva il rilascio di radioattività nell’ambiente. Il modulo centrale ha al suo interno moduli più piccoli e solo uno di questi, quello di controllo, è accessibile agli operatori; le altre parti della struttura sono sigillate in fabbrica, con il nucleo del combustibile già integrato. Il nucleare permette altresì che i dispositivi possano essere collocati sottoterra, per fornire un ulteriore livello di protezione contro eventi esterni naturali o deliberati.
Anche in questo caso il processo di ricerca e sviluppo è molto avanzato nel mondo. Il treno è partito e sarà difficile (e controproducente) fermarlo… Anche gli investimenti iniziali da parte dei privati sono sostenibili, e certamente non confrontabili con i notevoli fondi (per lo più pubblici) necessari per le grandi infrastrutture del passato, tenendo altresì conto del tempo molto ridotto che intercorre tra la fase di progetto e quella di sfruttamento commerciale della batteria. Molte compagnie internazionali dovrebbero produrre risultati già nei prossimi anni, con una serie di impianti pilota pronti a essere installati e messi in funzione in vari paesi del mondo. Sarà importante comunicare sulla sicurezza connaturata a questi impianti, ma sarà importantissimo arrivare a un basso costo del kilowattora per far prevalere l’intrinseca natura «verde» dell’energia prodotta.




