Mi è capitato ieri. Stavamo cenando e uno dei ragazzi ha fatto una battuta su qualcosa che aveva “visto fluttuare in cucina”. Gli ho chiesto, per provocarlo: «Ma tu lo sai cos’era YouTube?» Ha scosso la testa. Pensava fosse una bevanda.
Leggi anche: 2100, tra Intelligenze artificiali e robot non c’è più chi ha più bisogno di lavorare per avere, ma per essere
Dentro lo schermo
Nel 2100, i contenuti non si cercano. Ti trovano. Non esistono schermi, nè app, nè canali. L’idea stessa di “guardare qualcosa dentro un rettangolo” è diventata arcaica. Non è nostalgia. È storia della tecnologia. Ma come ogni storia, ha un punto cieco: nessuno ha più memoria del mezzo. Solo del messaggio.
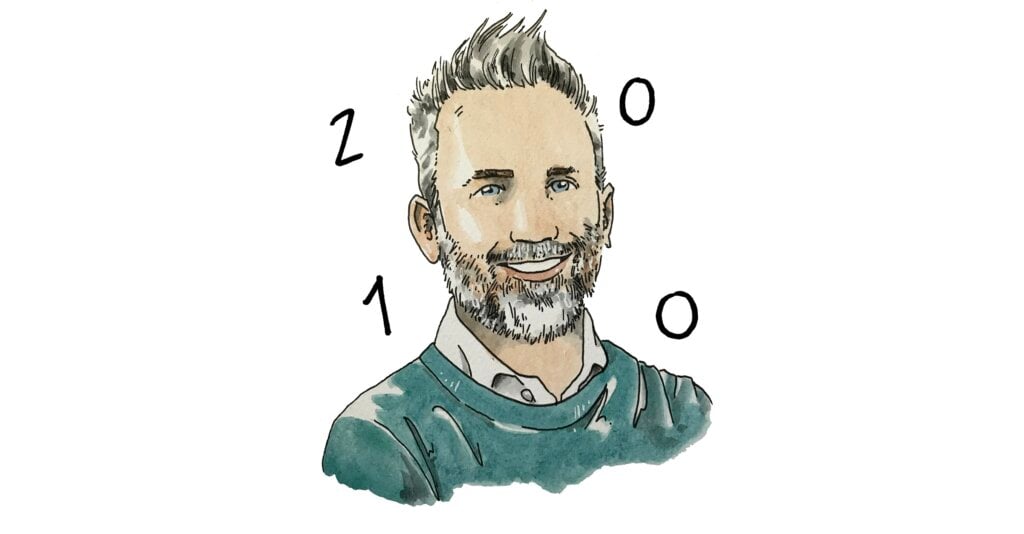
Abitare i contenuti
La transizione è iniziata quando abbiamo smesso di distinguere tra fisico e digitale. Prima gli occhiali, poi le lenti neurali, poi l’intelligenza ambientale. Oggi, ogni spazio è uno spazio informato. Le informazioni si manifestano, non si aprono. Gli oggetti sono interfacce. I gesti sono comandi. Le emozioni, segnali. Nessuno scrolla. Nessuno clicca. Si entra in un ambiente, e l’ambiente risponde.
I bambini non imparano più a usare uno strumento. Imparano a usare sé stessi per interagire. Lo chiamano comportamento immersivo. Non guardano un video: ci camminano dentro. Non leggono un testo: ci parlano. E ogni contenuto è solo una traiettoria attorno alla propria intenzione.

Sparizione dell’interfaccia
All’inizio era solo una moda: eliminare i device, rendere tutto fluido. Poi è diventata una scelta culturale. Oggi, non c’è più un luogo per i contenuti. Sono ovunque e in nessun posto. Ogni superficie è potenziale, ogni spazio è potenzialmente parlante. Non ci sono più icone, nè menu. Nessuna interfaccia da apprendere: c’è solo il contesto. E il contesto risponde.
YouTube, Netflix, perfino la TV: parole svuotate. I contenuti che prima cercavamo in piattaforme ora ci attraversano. Come emozioni che si manifestano quando servono, e svaniscono quando non ci servono più. Non è solo cambiato il modo di fruire. È cambiato cosa significa fruire.

Una nuova grammatica
Tutto questo ha trasformato anche il modo in cui raccontiamo. Il linguaggio narrativo si è spezzato. Non esiste più una timeline, né un montaggio. I contenuti sono persistenti, frammentati, relazionali. Ognuno esperisce un contenuto diverso, anche se il punto di partenza è comune. È la fine della trasmissione. L’inizio della compresenza percettiva.
In questo mondo, la creatività non è più “creare per un pubblico”, ma attivare un contesto che possa generare esperienze diverse. Siamo diventati tutti autori di ambienti. Curatori di possibilità.
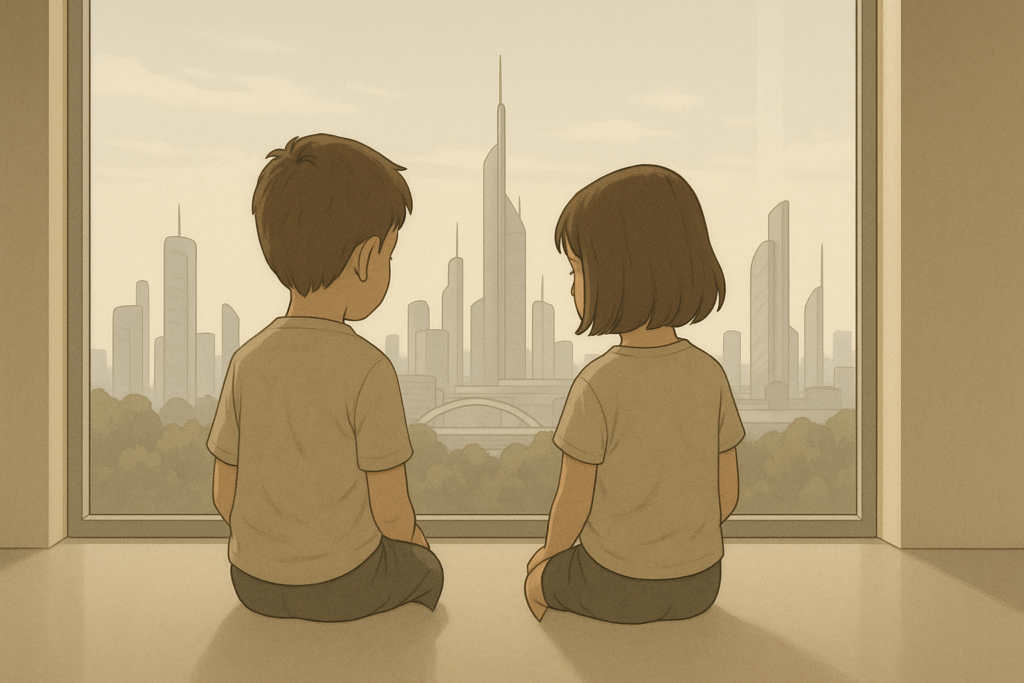
Ma cosa resta?
Ogni tanto, lo ammetto, mi manca la concentrazione verticale. L’attesa. Il rituale di scegliere cosa guardare. Di restare immobili davanti a un racconto. Oggi tutto è adattivo, reattivo, sensibile. Ma spesso è anche effimero.
Forse non è un problema. O forse sì. Perché se ogni contenuto è ovunque, ma non ha più un confine, quando diventa reale?
Il futuro non è una superficie da toccare. È uno spazio che ci attraversa. Ma anche gli spazi, se non li nominiamo più, finiscono per diventare invisibili. Proprio come gli schermi.



