Quali sfide attendono la società di domani? Quali sono i rischi e quali le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico? Per la rubrica “Futuro da sfogliare” un estratto del libro Food in Italy di Simonetta Pattuglia, edito da Guerini e Associati.
***
Pandemia, guerra e clima sono fenomenologie ad ampia e differente valenza – umana, primariamente, ma parimenti sociale, economica, imprenditoriale – che caratterizzano un periodo esteso di instabilità e di incertezza. Tanto che il dizionario inglese Collins ha decretato permacrisi come parola dell’anno 2022 a meglio identificare le sue caratteristiche e i suoi violenti impatti. Tali crisi permanenti si ripercuotono naturalmente sia sull’inflazione che abbiamo visto crescere negli ultimi anni a coincidere con il periodo post-pandemico e poi bellico, sia più specificatamente sulla produzione agricola anche a causa del cambiamento climatico e delle sue calamità (siccità, caldo estremo, alluvioni) e dell’aumento dei prezzi delle materie prime che nel 2023 hanno decretato il sorpasso della Germania sull’Italia, ora al terzo posto per produzione agricola. ISMEA afferma che la quota di mercato italiana è la più bassa in confronto ai Paesi partner dell’UE, seppur in crescita nell’ultimo decennio 2012-2022, e questo grazie alla crescita delle esportazioni agroalimentari italiane che si rivela superiore a quella delle esportazioni complessive mondiali. Sempre dai dati ISMEA, nel periodo 2012-2022, si è avuto il +7,6% di tasso medio annuo di crescita delle esportazioni agroalimentari italiane (+5,5% quello delle esportazioni totali di beni), con l’ultimo biennio al +13% nel 2021 e +15% nel 2022 (grazie all’aumento dei prezzi) raggiungendo un record di 61 miliardi di euro di export agroalimentare italiano nel 2022.
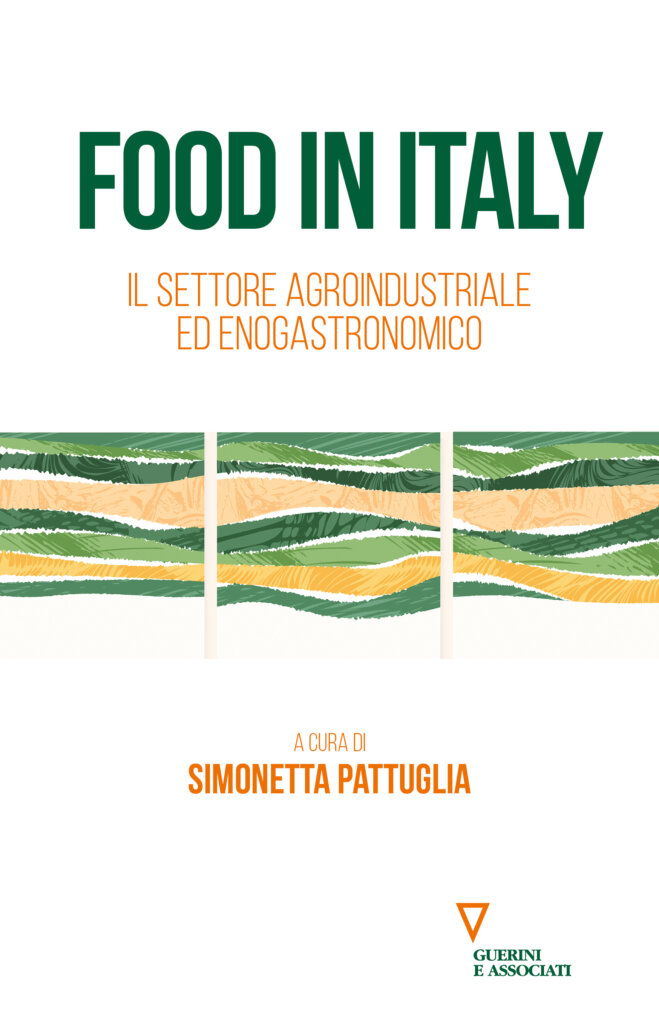
E questo malgrado l’Italia nel 2022 registri di fatto una crescita quasi doppia delle importazioni rispetto alle esportazioni, determinando un deficit della bilancia commerciale di –30,7 miliardi di euro (nel 2021, il saldo commerciale era invece pari a +40,3 miliardi). A contribuire al disavanzo commerciale è soprattutto l’energia, per effetto del forte rincaro dei valori medi unitari (e in particolare del gas naturale allo stato gassoso), accentuato dal conflitto in Ucraina.
In merito alla siccità che tanto ha funestato e funesta tuttora l’agricoltura, in Italia ci sono stati 250 giorni siccitosi nel 2021, con picchi in alcune zone di più di 300 giorni. Il 10% delle aree agricole ha sofferto di una siccità cosiddetta «severo-estrema». A proposito delle temperature in crescita, secondo le stime di ISPRA, il 2023 è stato il secondo anno più caldo mai registrato in Italia, con un’anomalia media pari a +1,07 °C rispetto alla media 1991-2020, di poco inferiore all’importante record del 2022 (+1,23 °C). Questi dati dimostrano che in Italia l’aumento delle temperature sta avvenendo sempre più velocemente e a un ritmo superiore alla media globale. Il cambiamento climatico, peraltro, già da vari anni è stato additato come uno dei motivi del possibile ricorso ai fitosanitari, e ad alti dosaggi degli stessi: l’UE chiede invece all’Italia di ridurne l’uso, rischiando una contrazione per le rese di grano duro. Si parla dunque di «rischio Italia»: il nostro Paese è tra i venti Paesi più esposti al mondo al rischio climatico, con un punteggio di 43,67/100 (Climate Risk Index, 2020) e se citiamo la biodiversità, avremo un vero e proprio «rischio agroalimentare», secondo il Global Risk Report WEF del 2023, per via del collasso ecologico entro dieci anni. Il clima è stato ulteriormente impietoso per la produzione agricola italiana – ma non solo – che nel 2022, in controtendenza rispetto al resto dell’economia nazionale, ha visto il valore aggiunto del settore agricoltura, silvicoltura e pesca calare dell’1,8%; in flessione anche il volume della produzione (–1,5%) e l’occupazione (–2,1%).
A tutto ciò, si aggiungono gli effetti negativi dell’inflazione post-pandemica. Infatti, il potere di acquisto si è ridotto di 6.700 euro pro capite negli ultimi due anni, con 27 milioni di italiani in difficoltà. Nel 2023, ci dice l’Istat, i prezzi nel comparto alimentare evidenziano un’accelerazione della crescita media annua, a +9,8% da +8,8% del 2022, nonostante l’attenuazione della loro dinamica tendenziale, evidenziata nella seconda metà dell’anno. I prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche sono aumentati del 21,3% in due anni, con previsione di ulteriore aumento del 4% nel 2024. Maggiori rincari si sono avuti nei reparti pet care e freddo con il +17%, nell’ortofrutta con il +14% e grocery con il +13,6%.
Le crisi e l’impatto sull’inflazione non riguardano solo noi: un’elaborazione Eurostat Allianz Research ci illustra l’impatto pro capite stimato dell’inflazione alimentare nell’Eurozona del +233%, con la Germania addirittura a +254%, la Spagna +200%, e l’Italia purtroppo a +229%.
I raccolti, anche i più tipici, sono stati profondamente colpiti dal cambiamento climatico in vari Paesi, non solo in Italia, e non solo in Europa, a dimostrazione del cambiamento climatico, e quindi della crisi, globale: secondo l’IFAD (2022), la Spagna ha visto una riduzione della produzione di olio di oliva del 35%, l’India un crollo del 15% nella produzione di riso e di pomodori (con l’aumento del prezzo dei pomodori del 450% in un anno), la Cina con rese in calo fino al 20% nelle coltivazioni.
Anche noi non ce la siamo cavata bene e purtuttavia la Commissione Europea non ha previsto un aumento delle risorse finanziarie per l’agricoltura, nonostante la crescente necessità.
La crisi della salute pubblica
Dal lato umano e individuale che, se letto sotto il profilo di chi è responsabile della collettività, diviene sistema di gestione della «salute pubblica», le permacrisi – e l’inevitabile maggiore diffusione della povertà che ne deriva – si trasformano anche in dati epidemiologici su alcuni fenomeni che cominciano a essere, oltre che qualitativamente, anche quantitativamente molto evidenti.
A fronte della malnutrizione di cui abbiamo parlato in precedenza, in aperta controtendenza, ci riferiamo innanzi tutto all’obesità, che una volta sembrava sintomo di ricchezza e oggi diviene simbolo di nutrizione sbagliata e poco accorta. Lo afferma la World Obesity Federation: l’impatto economico di sovrappeso e obesità supererà i 4 trilioni di dollari nel 2035.
Più della metà della popolazione globale vivrà in queste condizioni se prevenzione, trattamento e supporto non verranno prestati. La maggioranza della popolazione mondiale pari al 51%, ossia circa quattro miliardi di persone, vivrà in questa insalubrità entro il 2025 se continueranno a mantenersi questi trend di crescita. Una persona su quattro – ossia due miliardi di persone – vivrà nell’obesità. L’obesità infantile potrebbe addirittura raddoppiare entro il 2035 rispetto al 2020. Le quote raddoppieranno più nella popolazione femminile che in quella maschile e più nella popolazione giovanile che in quella adulta. In Italia, nel 2022, secondo l’Italian Barometer Diabetes Observatory Foundation, negli adulti sono oltre 25 milioni le persone in eccesso di peso, corrispondenti a più del 46% della popolazione totale, con oltre 5 milioni di obesi veri e propri. Il 26,3% è ricompreso tra bambini e adolescenti di 3-17 anni (2 milioni e 200mila persone). Dati che quindi ormai riguardano anche la Generazione Zeta e gli Alfa, con bambini e adolescenti in forte eccesso di peso.

Anche sul fronte delle malattie croniche correlabili all’alimentazione, i dati non sono rincuoranti. Nel 2022, tali malattie erano responsabili del 79% dei decessi nel mondo. A causa di malattie cardiovascolari in Italia, muoiono più di 230mila persone all’anno tra ischemie, infarti, malattie del cuore e cerebrovascolari. Questi dati, oltre che essere preoccupanti dal punto di vista morale, rendono la salute pubblica sempre più insostenibile dal punto di vista dei costi, perché naturalmente all’aumentare delle patologie (in particolare, le croniche), i costi pubblici si impennano.
Ponendo anche una questione non banale sulla «democraticità» del cibo salubre. Possiamo infatti affermare quanto il cibo, e non solo quello salubre (bio, genuino o quant’altro a causa di prezzi più alti anche del 40%), sia tendenzialmente sempre meno democratico: 2,6 milioni sono le persone in Italia – secondo dati Coldiretti (2023) – costrette a chiedere aiuto per mangiare, con una tendenza peraltro in aumento. Cambia anche, a causa dei prezzi, e non solo per i cambiamenti di stili alimentari, la composizione della spesa alimentare: carni rosse –14%; pesce –9%; salumi –8%; vino –6%; con la spesa effettuata ai discount al +12% sul 2021.
Cibo e diseguaglianze in crescita: la forbice che si allarga
La critica situazione complessiva in cui versano le nostre economie causa divari che pensavamo – sino alla fine del secolo scorso – ormai sulla via del ridimensionamento. Primariamente, un eccessivo divario economico che (non) si ripercuotesse eccessivamente sullo stile alimentare in quantità e qualità. I prodotti alimentari sostenibili in Italia sono invece oggi decisamente più costosi di quelli tradizionali. Il costo medio di un pasto sostenibile nel nostro Paese è del 20% superiore a quello di un pasto tradizionale, rendendo pertanto più difficile l’accesso a tale tipologia di alimentazione da parte delle fasce di popolazione con un reddito inferiore. Si tratta del fenomeno della «povertà alimentare» legata a problemi di insicurezza a causa dell’accesso economico al cibo e a una sana alimentazione.
Secondo i dati Eurostat – riporta l’Osservatorio Insicurezza e Povertà Alimentare – nel 2022, il 7,5% della popolazione italiana non poteva permettersi un pasto contenente carne, pesce o altro alimento vegetariano ogni due giorni. Considerando le persone a rischio di povertà nello stesso anno, la percentuale di popolazione che non può permettersi un pasto appropriato si attesta al 15,5%.
Il divario economico spesso si allinea a un divario geografico: in Italia, per esempio, il cibo sostenibile è spesso prodotto e distribuito in aree urbane. Legambiente (2023) afferma che il 70% dei prodotti alimentari sostenibili è venduto in tali aree del Paese, lasciando scoperte le zone periferiche. ASVIS, l’Alleanza per lo sviluppo sostenibile, in un’ideale «ruota» della giusta policy del cibo urbano contempla: il sistema economico alimentare fatto di bio-distretti, diritti dei lavoratori e accesso alla terra; una governance alimentare caratterizzata da trasparenza, condivisione, alleanze e processi partecipativi; specificità locali che si sostanziano in marchi, certificazioni e rispetto di paesaggi tradizionali; risorse naturali (suolo e produzione agricola) e reti alternative come l’agricoltura sociale e le reti di economia solidale; la sostenibilità del cibo che si concretizzi in standard della produzione e nella facilitazione di orti urbani; l’accurata gestione degli sprechi alimentari attraverso recupero, riutilizzo, gestione di sottoprodotti e di imballaggi; la dominante di diete sane e bilanciate attraverso informazione, sensibilizzazione, educazione multidisciplinare.
Questa forbice economica e geografica non può non coinvolgere e generare (ed esserne nel contempo generata) un divario culturale. A livello europeo, le persone con un livello di istruzione e di reddito più elevato sono più propense a scegliere alimenti sostenibili. Ben il 70% di tali persone – ci dice l’Eurobarometro (2022) – ritiene che sia importante mangiare in modo sostenibile. Forse perché se lo possono permettere?
Si amplia dunque – in costanza di crisi e nel contempo di sempre maggiore sensibilità verso la salubrità e la sostenibilità – la forbice nel rapporto fra cibo e diseguaglianze: il cibo aumenta di prezzo a monte e finale, e di varietà. Siamo più bravi a produrlo, per certi versi, e abbiamo capito qual è il cibo salubre. Al tempo stesso si verifica la non democraticità del cibo salubre: è sempre meno facile poter accedere al cibo sano nel senso che è sempre meno facile avere la capacità economica per potervi accedere.
In Italia, ad esempio, possiamo affermare che le persone che soffrono di insicurezza alimentare severa o moderata sono circa 3,4 milioni nel 2022. Ben il 20% dei bambini italiani – e questo è un dato tristissimo e sconosciuto ai più – vive in povertà assoluta. Per Oxfam, stiamo vivendo nel decennio dei grandi divari: «Ogni crisi ha ampliato i divari di lungo corso e rischia di acuire ulteriormente le disparità, lasciando troppe persone indietro e aumentando l’area della fragilità e vulnerabilità».
Nell’Unione Europea, il numero di persone in povertà alimentare è aumentato di 10 milioni di unità nel 2022 (+2,2%), raggiungendo l’ammontare di 105 milioni di individui a livello continentale e l’8,6% della popolazione che non può permettersi un pasto adeguato.
A livello mondiale, infine, nel 2022 circa 828 milioni di persone non hanno avuto accesso a cibo sicuro. Secondo i dati Istat, la «povertà alimentare» ha a che fare con la scarsità di accessibilità economica e fisica, di adeguatezza nutrizionale, di disponibilità e utilizzo, e coinvolge la dimensione umana e collettiva emozionale, psicologica, sociale, culturale.
Come sta reagendo il sistema?
Nascono nuovi «ecosistemi produttivi»
Nelle nostre economie capitaliste postindustriali ma anche in quelle che vedono in noi modelli da seguire, il «sistema del cibo», fatto di agricoltura e di sistema industriale di trasformazione e distribuzione, di mercati di sbocco ma anche di integrazione profonda con settori emergenti (ed emersi) e diverse nuove filiere, sta tentando di reingegnerizzarsi, anche alla luce dei nuovi grandi catalizzatori quali la tecnologia in genere e la digitalizzazione, in particolare, la salubrità sempre più attesa dai consumatori, la sostenibilità.
La nutraceutica e gli integratori alimentari, per esempio, rientrano pienamente nel settore wellness e wellbeing intersecando il settore farmaceutico, medico e biotecnologico, di conseguenza il settore alimentare nel suo complesso così come risulta dalla ricerca empirica. Tali settori intersecano a loro volta lo sport, i servizi pubblici della sanità, fino a influire sulla definizione dei comportamenti delle persone e delle comunità.
Nascono quindi sistemi, subsistemi, segmenti delle filiere integrate fra cibo, benessere, sport, farmaceutica e nutraceutica, biotecnologie e salute, proprio a far capire quanto anche le altre filiere produttive, una volta immaginate separate verticalmente, ad esempio quella dello sport, vista nel passato solo come agonismo, travalichino oggi di fatto il loro tradizionale perimetro grazie all’innovazione di prodotti e di processi, in termini di evoluzione verso l’integrazione e la convergenza con il sistema agroindustriale.
Ma potremmo allargare le intersezioni alle aziende di tutti i settori industriali, alle scuole e alle università, e all’apparato pubblico in generale, attraverso le mense e la ristorazione collettiva, come vedremo nel prosieguo del volume; e a tutte le forme ricreative e di entertainment, di turismo, attraverso la ristorazione, l’enogastronomia e i percorsi turistici, come pure vedremo; all’educazione e alla formazione che tutti i settori possono trasversalmente ricomprendere e integrare attraverso la gestione delle risorse umane e delle politiche di attenzione rivolte al personale; al marketing, alla comunicazione e ai media che sono oggi settori e funzioni aziendali abilitanti tutti gli altri.




